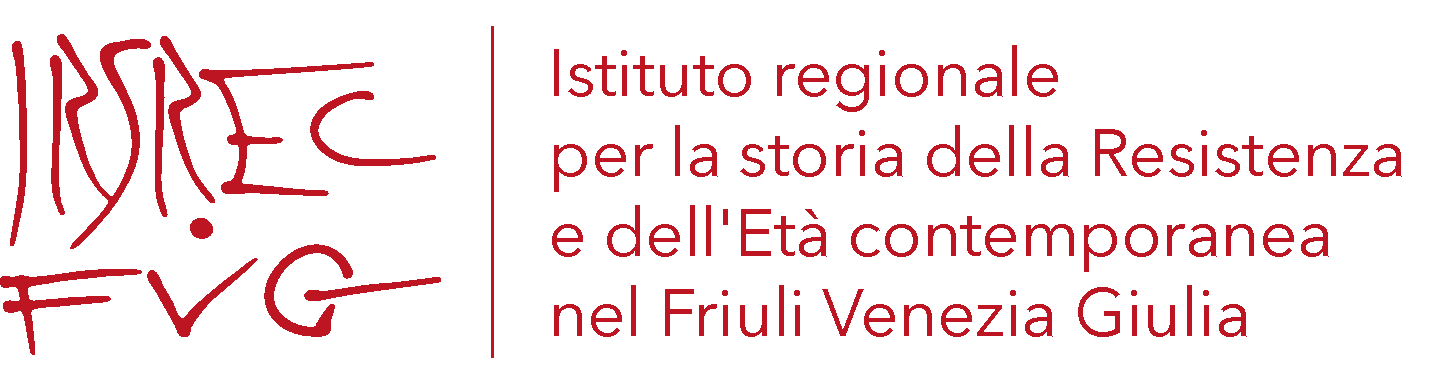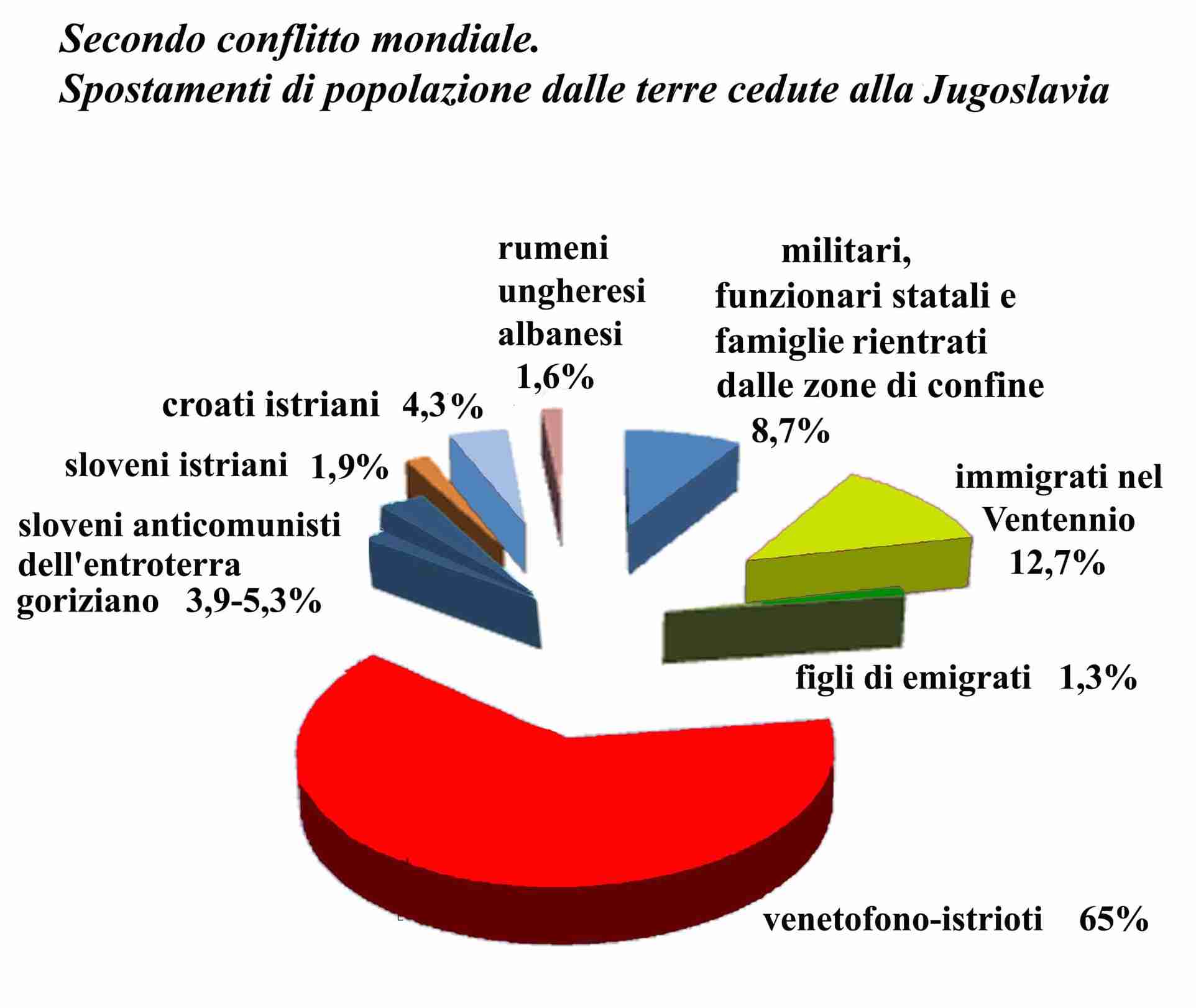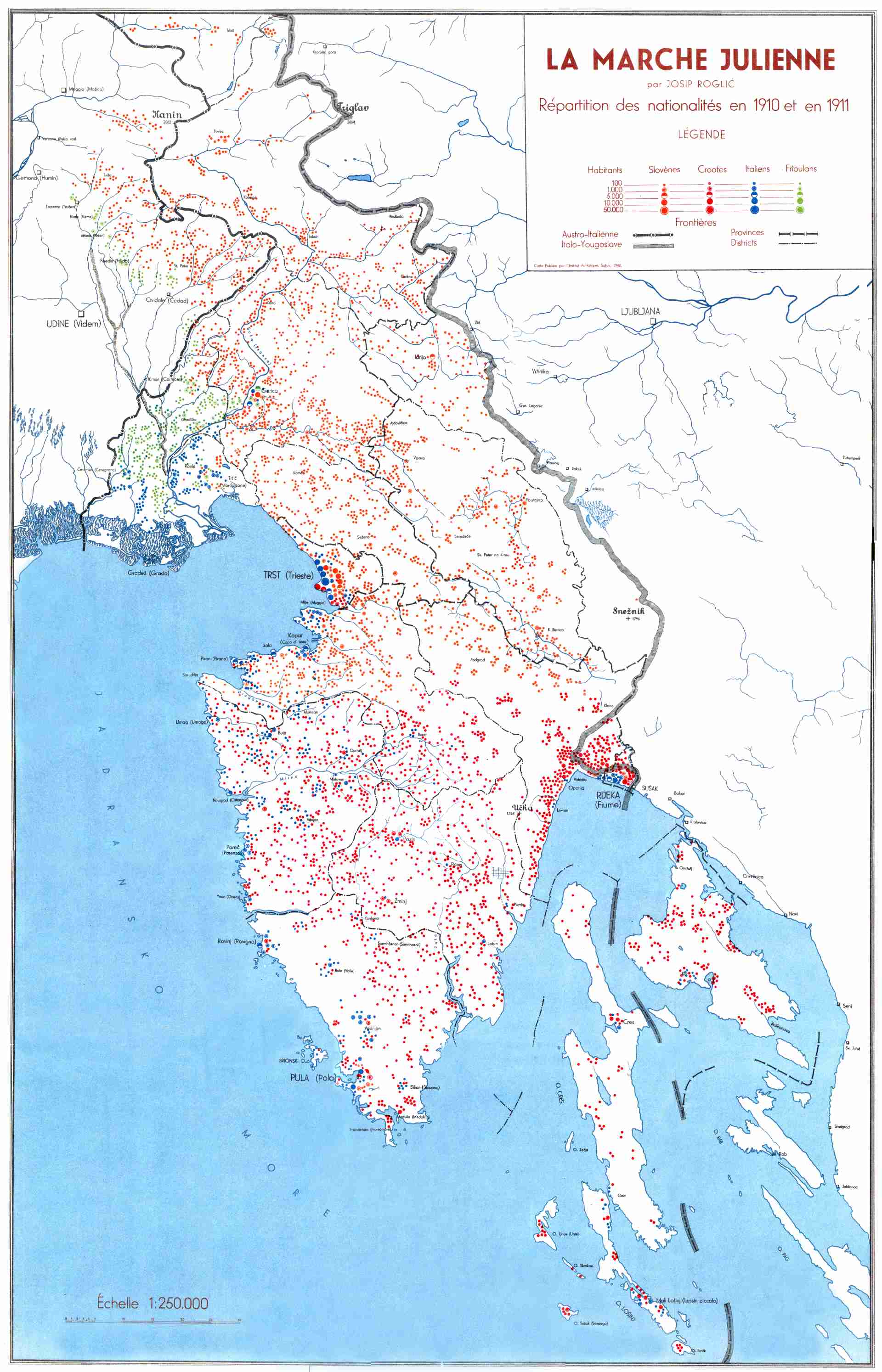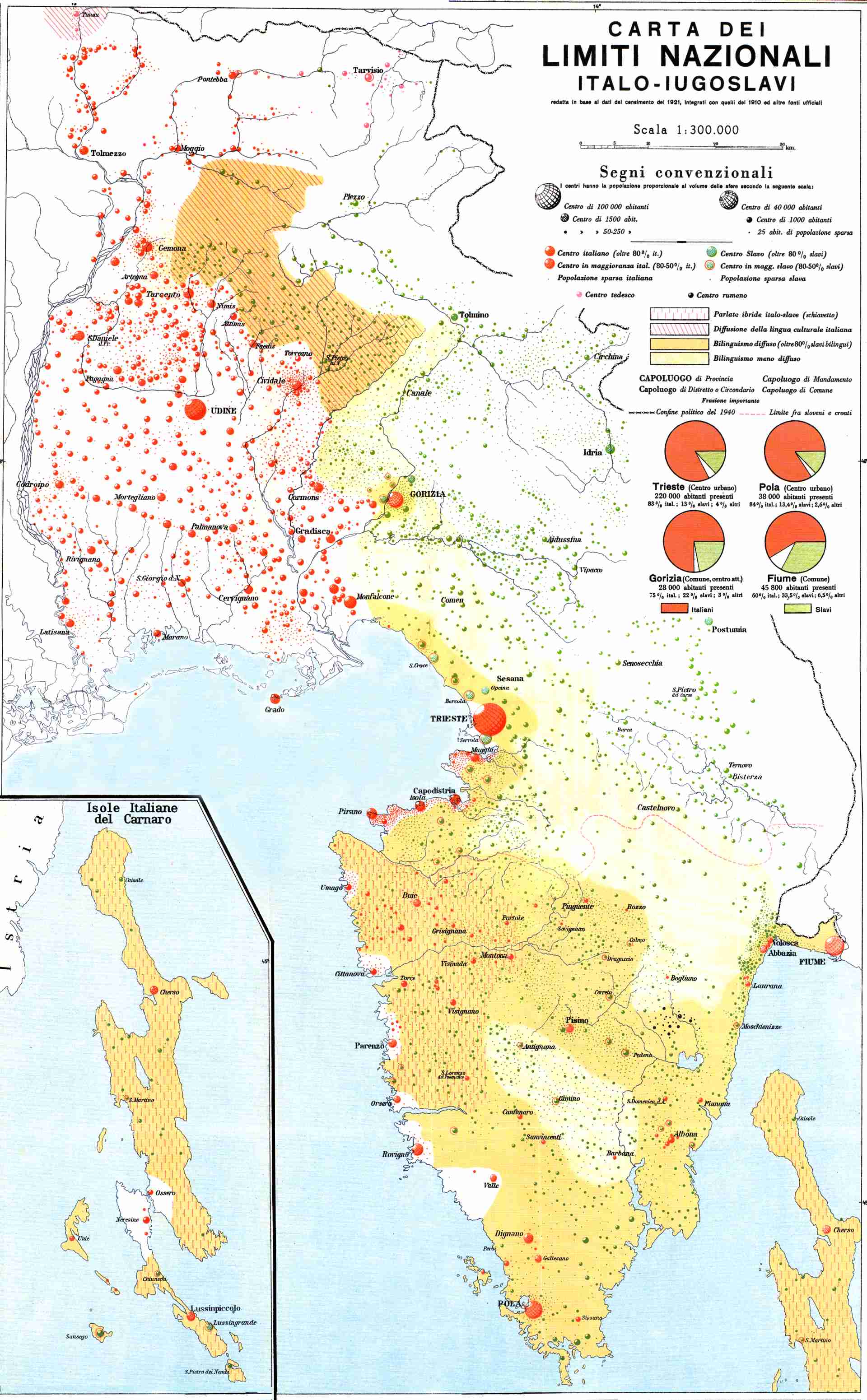Vademecum per il Giorno del Ricordo - Seconda edizione
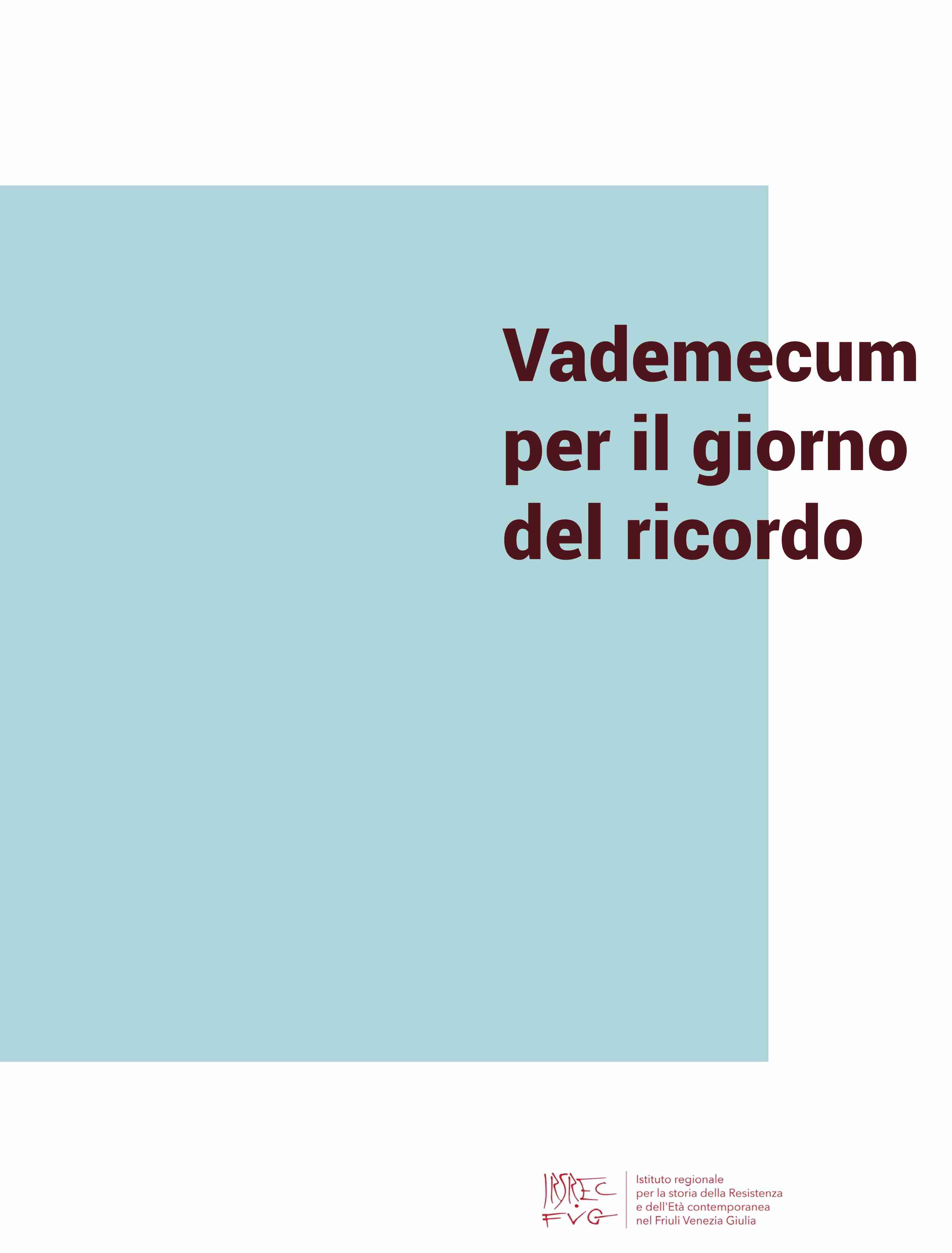
VADEMECUM PER IL GIORNO DEL RICORDO
In questa seconda edizione, abbiamo tenuto conto delle osservazioni e richieste che ci sono pervenute nei mesi scorsi.
Ad esempio, ci è stato fatto giustamente notare che la storia della crisi adriatica non comincia nel 1918, perché le conflittualità nazionali erano di più lunga data. Così, abbiamo aggiunto altre tre schede riguardanti I conflitti nazionali, L'irredentismo italiano e L'irredentismo sloveno e croato.
Abbiamo poi riformulato la voce Negazionismo, per articolarla meglio e fare un po' di chiarezza sui correlati termini Riduzionismo e Giustificazionismo.
Nella sezione sulla memoria, abbiamo inserito una nuova scheda per mettere a fuoco il rapporto fra Memoria e storia ed abbiamo ripreso il tema nelle FAQ, per discutere di Memoria condivisa e Percorsi di riconciliazione.
Sempre nelle FAQ, abbiamo affrontato la questione, che ci è stata molte volte proposta, del possibile paragone tra foibe, esodo e Shoah.
Infine, nella sezione dedicata alle immagini abbiamo cercato di spiegare quali sono sia i limiti che le possibilità di utilizzo didattico delle cosiddette "carte etniche", che tanta fortuna hanno avuto il secolo scorso sia fra gli studiosi che fra i politici dalle varie parti del confine.
Naturalmente, non credo proprio che abbiamo accontentato tutti, né questo del resto è lo scopo del prodotto. La finalità rimane infatti quella della prima edizione: offrire uno strumento di prima consultazione, il più possibile rigoroso anche se sintetico, a quanti (in primo luogo giornalisti, insegnanti, politici) hanno bisogno di un'informazione di base sui temi legati al Giorno del ricordo nell'imminenza del 10 febbraio. Per questo, ci siamo impegnati ad utilizzare un linguaggio il più possibile neutro (le passioni poi, se ritengono, le reitrodurranno gli utenti) ed abbiamo cercato di offrire risposta ai quesiti che più frequentemente ci vengono rivolti da molti anni a questa parte.
Ogni anno, nell’imminenza del 10 febbraio, operatori politici, della comunicazione e della scuola si trovano a dover commentare i passaggi cruciali di una storia obiettivamente complessa come quella della Frontiera adriatica nel ‘900. Nella miriade di voci è difficile trovare informazioni rigorose e sintetiche, mentre abbondano semplificazioni e deformazioni interpretative. Il Vademecum vuole offrire un contributo di chiarezza e praticità di consultazione. Il prodotto è suddiviso in capitoli, in ordine cronologico: questioni generali, fascismo di confine, occupazioni italiane in Jugoslavia, foibe, esodo. Segue poi una sezione dedicata alle domande più frequenti. Ulteriori strumenti sono una bibliografia sintetica, le foto e le mappe storiche, tutte libere da diritti. I testi sono di Gloria Nemec, Raoul Pupo, Fabio Todero e Anna Vinci, le mappe di Franco Cecotti. La cura è di Raoul Pupo. Il testo originale, pubblicato nei primi mesi del 2019, è stato integrato alla fine del medesimo anno in modo da tener conto delle osservazioni e richieste di chiarimento pervenute da parte di alcuni lettori, che qui si ringraziano. Nel testo sono stati inseriti anche alcuni link ad altri prodotti multimediali dell’Irsrec, la cui consultazione può aiutare ad approfondire le tematiche del Vademecum: alcuni sono già attivi, altri lo diventeranno nel corso del 2020.
Il Vademecum non vuol essere un compendio generale di storia delle regioni adriatiche, ma un sussidio specifico dedicato a chi si trova ad occuparsi dei temi maggiormente legati alla celebrazione del Giorno del Ricordo. Non vengono perciò in questa sede affrontati altri problemi di pur fondamentale importanza per la storia di confine, quali l’occupazione nazista ed i movimenti resistenziali, che troveranno posto invece in un Vademecum Resistenza al confine italo-jugoslavo, che verrà attivato nel corso del 2020.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
Per leggere la licenza cliccare qui https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it
In particolare con questa licenza:
Tu sei libero di:
Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato
Alle seguenti condizioni:
Attribuzione — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.
NonCommerciale — Non puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali.
Non opere derivate — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire il materiale così modificato.
Divieto di restrizioni aggiuntive — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.
Cliccare qui per il pdf del Vademecum
INDICE
QUESTIONI GENERALI: Frontiera adriatica; Venezia Giulia; Etnia e nazione; Territorio etnico; Italianità adriatica; Questione adriatica; Conflitti nazionali; Irredentismo italiano; Irredentismo sloveno e croato; Pulizia etnica; Negazionismo/Riduzionismo/Giustificazionismo
FASCISMO DI CONFINE: ideologia; squadrismo; bonifica etnica
OCCUPAZIONI ITALIANE IN JUGOSLAVIA: Annessioni italiane; Crimini di guerra italiani
FOIBE: definizione; utilizzi; Foiba di Basovizza; Foibe (simbolico); Foibe istriane; Foibe giuliane; Foibe (quantificazione); Foibe 1945 (Rapporto finale della Commissione storico-culturale italo-slovena); Infoibati
ESODO: definizione; Esodo dei giuliano dalmati (ondate); Esodo dei giuliano dalmati (motivazioni); Esodo dei giuliano-dalmati (strategia delle autorità); Esodo dei giuliano dalmati (Opzioni); Esodo dei giuliano-dalmati (crisi del Cominform); Esodo dei giuliano-dalmati (Controesodo); Esodo dei giuliano dalmati (accoglienza); Esodo dei giuliano dalmati (Italiani rimasti)
QUESTIONE DI TRIESTE: Corsa per Trieste; Crisi di Trieste; Trattato di pace; Territorio Libero di Trieste; Memorandum di Londra
AMNESIE E RICORDI: Memoria e storia; Memorie divise; Dalla sovraesposizione al silenzio; La riscoperta e il ricordo
Nell’autunno del 1943 come furono accolti i tedeschi in Istria?
È vero che gli infoibati vennero gettati negli abissi ancora vivi?
È vero che nelle foibe vennero gettati anche donne e bambini?
Le foibe avevano lo scopo di far fuggire gli italiani dalla Venezia Giulia?
Le foibe furono una “resa dei conti”?
Le foibe furono un atto di genocidio?
Le foibe giuliane furono un atto di “pulizia etnica”?
Le foibe furono una repressione per categorie?
Le foibe furono una repressione per quote?
Le foibe furono la causa dell’esodo?
L’esodo fu indotto dalla propaganda del governo italiano?
L’esodo fu un atto di “pulizia etnica”?
Si possono paragonare le foibe alla Shoah?
Si può paragonare l’esodo alla Shoah?
Riguardo alle città italiane come Zara, Fiume, Pola e Capodistria si può parlare di urbicidio?
A chi è corretto attribuire la colpa della perdita dell’Istria e dell’esodo dei giuliani dalmati?
È possibile puntare ad una memoria condivisa delle genti di frontiera (italiani, sloveni e croati)?
È possibile riconciliare le memorie delle genti di frontiera (italiani, sloveni e croati)?
APPARATO ICONOGRAFICO
Mappe e immagini libere da diritti, possono essere riutilizzate citando la fonte
Cliccare qui per andare alle carte etniche
Cliccare qui per vedere le immagini
É la lunga fascia costiera dell’Adriatico orientale che dal golfo di Trieste scende fino al Montenegro. Si tratta di una zona di sovrapposizione fra periferie: quelle dei mondi latino, germanico e slavo, con alcune presenze ungheresi. Al suo interno sono state tracciate nel tempo molteplici linee di confine. Come in molti altri casi, i numerosi incroci linguistici e culturali hanno reso più ricche di complessità le società di frontiera, ma hanno anche generato forti conflittualità.
Per approfondimenti sul tema si segnalano due approfondimenti metodologici presenti sul sito www.regionestoriafvg.eu, precisamente Che cos'è un confine? e Storia di confini e di cartografie nell’Alto Adriatico
Definizione coniata nel 1863 dal glottologo goriziano Graziadio Isaia Ascoli per offrire un nome alternativo alla provincia austriaca del Litorale. Secondo Ascoli, nell’Italia nord-orientale esisteva una grande regione veneta, accomunata dal dialetto sostanzialmente simile parlato dalle popolazioni ivi residenti (Ascoli si riferiva solo alle popolazioni romanze, non tenendo conto degli slavofoni). Questa macro-regione si poteva a sua volta suddividere in Venezia Euganea, Venezia Tridentina e Venezia Giulia. La teoria delle “tre Venezie” ebbe grande fortuna nella cultura politica italiana e tale terminologia venne adottata per denominare ufficialmente i territori del Tirolo meridionale e del Litorale annessi dopo la prima guerra mondiale. La Venezia Giulia venne a sua volta suddivisa amministrativamente nelle province di Gorizia, Trieste, Pola e Fiume. Dopo la seconda guerra mondiale ed il lungo dopoguerra (vedi la voce Questione Adriatica), all’Italia rimasero solo la parte meridionale della provincia di Gorizia (con il capoluogo e la cittadina di Monfalcone) ed una minima parte di quella di Trieste (con il capoluogo e cinque altri comuni). All’interno della Venezia Giulia si distinguono solitamente il Goriziano (la valle dell’Isonzo), Trieste, il Carso (altipiano retrostante la città) e l’Istria. Nelle culture politiche slovena e croata il termine non esiste, anche se viene tradotto con Julijska Krajina. Le denominazioni più usate sono invece: Primorje (Litorale) per definire tutto il territorio comprendente la valle dell’Isonzo ed i suoi affluenti, nonché il Carso triestino e la costa fino al fiume Dragogna; Istra (Istria), comprendente tutti i territori a sud del fiume medesimo, ora appartenenti alla repubblica di Croazia.
Etnia e nazione non sono sinonimi. Confonderli – come spesso avviene nel linguaggio comune, nell’uso pubblico ed in quello mediatico – può generare gravi fraintendimenti, specie quando si parla della storia adriatica. Per nazione intendiamo una comunità immaginata (cioè i cui membri non si conoscono tutti), in base ad un numero assai variabile di parametri che non sempre si danno assieme ed in alcuni casi sono fra loro contraddittori (lingua, cultura, insediamento storico, ereditarietà, religione, storia comune, valori condivisi, ecc.).
Fra i diversi modelli di nazione, in Europa nel XIX e XX secolo due hanno avuto principale rilevanza. Il modello francese è di tipo volontarista (plebiscito di ogni giorno): si fonda sulla decisione individuale di appartenenza, a prescindere dai fattori naturalistici (ereditarietà, madrelingua). É un modello fortemente inclusivo, che favorisce l’integrazione. Il modello tedesco è di tipo etnicista (sangue e terra): si fonda su criteri naturalistici (ereditarietà), è naturalmente meno inclusivo ed è pensato per favorire la difesa dall’assimilazione a nazioni culturalmente più sviluppate.
Per questi motivi, nell’area adriatica gli italiani hanno storicamente adottato il modello francese, che risponde perfettamente alle esigenze di comunità socialmente e culturalmente sviluppate, dotate di un forte potere di attrazione. La lingua italiana (nella sua versione veneta) e la cultura italiana, assieme ai vantaggi di status legati all’italianizzazione, sono state infatti capaci di assimilare nel corso dei secoli gli apporti provenienti sia dal Mediterraneo orientale che dall’entroterra slavo.
Viceversa, gli slavi hanno adottato la concezione tedesca, che meglio consentiva alle comunità slovene e croate, in genere socialmente e culturalmente sviluppate, di resistere all’assimilazione alla nazione italiana, dapprima culturale e poi anche politica.
Con tale formula gli aderenti ai movimenti nazionali sloveno e croato intendevano il territorio in cui era storicamente insediata un’etnia rurale, a prescindere dal fatto che in esso si trovassero anche centri urbani appartenenti ad altre nazionalità (nella Venezia Giulia, italiani). Il territorio etnico croato comprendeva le intere Istria e Dalmazia, mentre il limite occidentale del territorio etnico sloveno era considerato il fiume Isonzo. Pertanto, tutte le aree ad oriente di tale linea erano rivendicate quali parti integranti della Croazia e della Slovenia, e quindi, nel primo dopoguerra del Regno dei serbi, croati e sloveni (SHS); nel secondo, della Repubblica federativa jugoslava. La categoria di “territorio etnico” ovviamente ha senso solo all’interno di una concezione etnicista della nazione (vedi la voce Etnia e nazione). Nella cultura politica italiana essa non esiste.
É la forma storicamente assunta nel XIX e XX secolo, a seguito del processo di nazionalizzazione, da una presenza italiana di assai più lunga data sulle sponde orientali dell’Adriatico. Connotati tipici di tale presenza secolare, fra loro strettamente connessi, erano soprattutto i seguenti:
1) Il carattere marittimo, in un contesto storico in cui, fin dalla prima antichità, ricchezze, idee, innovazione venivano dal mare.
2) L’inclusività, perché la sua origine era doppia: in parte etnica, vale a dire la continuità con il popolamento romanzo, ben evidente nelle principali città; in parte frutto di integrazione degli apporti provenienti sia dal mare (penisola italica e Mediterraneo orientale) che dall’entroterra.
3) Il carattere urbano, anche questo in continuità con la tradizione prima romana e poi dei comuni medievale italiani, secondo la quale la città è il fulcro di quella che, appunto, viene chiamata vita civile o, più semplicemente, civiltà.
4) Il potere, vale a dire l’egemonia sociale, culturale e politica.
É la competizione per il controllo dell’Adriatico, sviluppatasi dapprima fra Italia e Austria, poi fra Italia e Jugoslava. L’Austria era la dominatrice del mare, grazie al possesso della costa dalmata, frastagliata e ricca di porti, ed alla superiorità della sua flotta mercantile con base a Trieste e Fiume. Dopo la prima guerra mondiale la superiorità passò all’Italia, grazie all’annessione di Trieste, l’Istria, Fiume e Zara, mentre la Jugoslavia, per pur possedeva la Dalmazia, non era dotata di flotte né militari né mercantili competitive. Durante la seconda guerra mondiale l’Italia trasformò la sua superiorità in controllo totale, con l’occupazione della Dalmazia e del Montenegro. Dopo l’8 settembre 1943 la potenza italiana collassò. Nel dopoguerra, perdute Zara, Fiume e l’Istria, l’ultima fase della Questione adriatica fu la Questione di Trieste, cioè il conflitto diplomatico per l’appartenenza statuale del capoluogo giuliano. La Questione si concluse nel 1954 con il Memorandum di Londra, grazie al quale l’Italia riottenne il controllo di Trieste.
I movimenti nazionali, italiano da un lato e sloveno e croato dall’altro, cominciarono a confliggere soprattutto a partire dagli anni ’80 dell’800, come conseguenza dei fenomeni di nazionalizzazione parallela competitiva che interessarono tutti i gruppi linguistici all’interno dell’area asburgica [per approfondimenti si segnalano i seguenti link al sito www.regionestoria.fvg.eu: Il movimento nazionale italiano a Trieste; Il movimento nazionale italiano in Istria; Il movimento nazionale sloveno nel Litorale e Il movimento nazionale croato in Istria]. Nella parte austriaca dell’Impero le nazionalità linguistiche erano infatti riconosciute per legge, ma non era ammessa la loro trasformazione in entità politiche.
I movimenti nazionali erano fra loro diversi per ispirazione (vedi la voce Etnia e nazione), ma condividevano alcuni orientamenti di fondo, come la tendenza all’intolleranza e la concezione secondo la quale il territorio appartiene alla nazione che lo abita. Naturalmente, quando nel medesimo territorio abitano più gruppi nazionali, ne segue il conflitto, alimentato da: pregiudizi; volontà di nazionalizzare le masse, che spesso si trovavano ancora in una condizione di indifferentismo nazionale, legato anche al diffuso bilinguismo dialettale; ricerca spasmodica di determinare maggioranze e minoranze (spesso manipolando i dati); costruzione di narrazioni in cui la nazione preferita viene presentata come residente “da sempre” sul territorio e l’altra come straniera, venuta dopo, importata da poteri ostili.
Come nel resto dell’Impero, il governo di Vienna cercò di bilanciare il monopolio di una nazione a livello locale. Infatti, nel sistema amministrativo asburgico, fortemente decentrato, una minoranza numericamente marginale a livello statale, ma fortemente presente in un territorio ristretto, poteva amministrarsi quasi autonomamente. Nel Litorale (Goriziano, Trieste, Istria) il potere nella società e nella politica era unicamente in mano agli italiani, per ragioni storiche ed economiche. Il governo quindi guardò con favore ed in alcuni casi direttamente sostenne le rivendicazioni slovene e croate, anche perché dopo le tre guerre d’indipendenza diffidava sempre più degli italiani. Le rivendicazioni nazionali slovene e croate si esprimevano invece sempre all’interno della cornice imperiale. A sua volta, l’appoggio delle autorità statali ai movimenti nazionali slavi esacerbò il sentimento nazionale dei patrioti italiani, spingendoli verso l’irredentismo (vedi la voce Irredentismo italiano). Un impulso in tale direzione venne dal “precedente dalmata”. Sino agli anni ’70 dell’800 infatti, egemone nella regione era il partito autonomista, espressione dei ceti urbani, etnicamente misti ma di lingua e cultura italiana. Successivamente invece, l’allargamento del suffragio alle masse rurali e l’appoggio dei rappresentati dello stato asburgico favorirono l’ascesa del movimento nazionale croato, che riuscì ad assicurarsi il controllo della Dieta provinciale e dei principali comuni, con la sola eccezione di Zara. Ne seguì il collasso dell’italianità dalmata. Verso la fine del XIX secolo tra i patrioti italiani si diffuse il timore che la medesima situazione si potesse prima o poi ripetere anche a Trieste ed in Istria, dove peraltro gli italiani erano assai più numerosi.
Dopo la Grande guerra, l’Impero multinazionale fu sostituito da stati nazionali (che sarebbe più corretto chiamare “stati per la nazione”). Di conseguenza, i patrioti della nazione la cui madrepatria aveva ottenuto il controllo della regione poterono schierare tutta la forza dello stato contro i loro avversari. Ciò accadde nel primo dopoguerra a danno degli sloveni e croati, mentre invece nel secondo dopoguerra a danno degli italiani.
Nel 1877 il patriota ed ex garibaldino italiano Matteo Renato Imbriani coniò la formula «terre irredente»: l’aggettivo, tipico della “religione della patria”, indicava le regioni dell’Impero degli Asburgo che ospitavano comunità di italiani ancora separate dalla madre patria, vale a dire il Trentino, la Venezia Giulia e la Dalmazia. Imbriani fondò la Società Pro Italia irredenta la cui presidenza onoraria fu assegnata a Giuseppe Garibaldi. Le radici del movimento ‒ ben presto affiancato dalla massoneria [per un approfondimento si segnala, sul sito www.regionestoriafvg.eu, la voce Massoneria e Irredentismo ‒ affondavano dunque nel terreno del mazzinianesimo e del garibaldinismo. Il termine ebbe pronta diffusione e si estese anche ad altri contesti europei, dove esistevano gruppi nazionali incorporati in contesti statuali diversi, e che desideravano essere uniti allo stato-nazione di riferimento. Per un approfondimento su questa tematica si segnala la voce Irredentismo.
Le aspirazioni degli irredentisti italiani furono tuttavia a lungo osteggiate dal governo di Roma che, sottoscritta la Triplice alleanza, era più interessato all’espansione coloniale che a battersi nuovamente contro l’Austria. L’irredentismo assunse così una dimensione prevalentemente ‒ ma non esclusivamente ‒ culturale e mirò a difendere le tradizioni linguistiche, letterarie e artistiche del gruppo italiano, coltivando i legami con la madre patria. Di qui anche l’importanza delle battaglie sostenute per la difesa della scuola italiana. Non mancarono tuttavia gesti clamorosi, come alcuni attentati eseguiti da gruppi di cospiratori, soprattutto a Trieste. In particolare, il giovane triestino Guglielmo Oberdan (nato Wilhelm Oberdank, madre goriziana slovena e padre proveniente dal Lombardo-Veneto, all'epoca dominio imperiale) progettò di uccidere l’imperatore Francesco Giuseppe e per questo fu condannato a morte (1882), divenendo il “protomartire” dell’irredentismo. Si segnala il progetto "Oberdan tra noi" realizzato dall'Irsml FVG con il contributo del Comune di Trieste e dagli alunni della IV G del Liceo scientifico «G. Oberdan» di Trieste (a. s. 2011-2012).
Mentre nascevano nuove organizzazioni di ispirazione irredentista come la Lega nazionale (1891) e diverse associazioni sportive, il movimento assunse le caratteristiche dei movimenti politici di massa e si avvicinò al nazionalismo. Alla vigilia della Grande guerra, a Trieste si potevano distinguere un “irredentismo culturale” (Scipio Slataper, Giani Stuparich) che voleva fare della città un ponte fra mondo latino, germanico e slavo, ed un irredentismo imperialista (Ruggero Timeus) che assegnava invece a Trieste il ruolo di trampolino per l’espansionismo italiano nell’Europa centrale. A Fiume, irredentista fu soltanto una pattuglia di giovani, mentre la maggior parte degli italiani aderiva al partito autonomista, che si batteva per la difesa dell’identità italiana ma sempre all’interno del Regno di Ungheria, di cui Fiume era Corpo Separato. Per un approfondimento si segnala, sul sito www.regionestoriafvg.eu, la voce Autonomismo fiumano. In Dalmazia gli autonomisti si convertirono all’irredentismo solo allo scoppio della guerra.
Dopo l’entrata in guerra dell’Italia, molti giovani irredentisti, a prescindere dai precedenti orientamenti, si arruolarono nell’esercito italiano, aggiungendo ai rischi di guerra quello di venir giustiziati come traditori se catturati degli austriaci. Fu questo il caso del capodistriano Nazario Sauro, simile a quello del trentino Cesare Battisti. Altri caddero in combattimento come i triestini Guido Brunner, Spiro Xidyas, Scipio Slataper, Carlo Stuparich, Ruggero Timeus, il capodistriano Guido Corsi, il dalmata Francesco Rismondo (che si ritenne a lungo essere stato giustiziato). In Austria le organizzazioni irredentiste vennero sciolte ed i loro esponenti arrestati o internati, mentre le sedi dei circoli e dei giornali irredentisti a Trieste vennero devastati fra il 23 e il 24 maggio 1915. Sull'incendio del Piccolo si rimanda al progetto "Le vie della memoria. Un percorso tra le violenze del Novecento nella Provincia di Trieste", in particolare alla scheda "L'assalto al Piccolo"
L’irredentismo sloveno e croato prese corpo nel primo dopoguerra. Nel periodo asburgico infatti i movimenti nazionali slavi operanti nel Litorale ed in Istria avrebbero preferito la formazione di una compagine degli slavi del sud autonoma, ma all’interno della cornice imperiale asburgica, come già accadeva per l’Ungheria. [Per un approfondimento si segnala, sul sito www.regionestoriafvg.eu, le voci Il movimento nazionale sloveno nel Litorale e Il movimento nazionale croato in Istria]. Dopo il 1918 invece i patrioti sloveni e croati si batterono per l’annessione al Regno dei serbi, croati e sloveni, ma invano. Dopo l’annessione all’Italia, i leader sloveni e croati mostrarono lealismo nei confronti del nuovo stato, anche dopo l'avvento del fascismo; tra l'altro, essi non aderirono all'opposizione legale quando nel 1924 essa si ritirò sull'Aventino in segno di protesta contro il delitto Matteotti. Contemporaneamente, con il sostegno dei servizi segreti jugoslavi si formarono alcuni piccoli nuclei cospirativi sloveni che collaborarono con alcuni militanti dell'organizzazione nazionalista jugoslava ORJUNA, per compiere azioni di sabotaggio lungo il confine. [Per un approfondimento si segnala, sul sito www.regionestoriafvg.eu, la voce TIGR].
Dopo l’avvio della politica snazionalizzatrice, gruppi di giovani ex dirigenti delle organizzazioni nazionaliste slovene e croate si riunirono in clandestinità e costituirono il movimento TIGR (Trst, Istra, Gorica, Rijeka). Il TIGR pubblicò il giornale clandestino “Borba” (lotta) e svolse attività propagandistica e di lotta armata, inizialmente anche in collegamento con la formazione antifascista italiana “Giustizia e libertà”. Quest’ultima cessò la sua collaborazione quando il TIGR esplicitò i suoi obiettivi irredentisti. Vittime delle azioni terroriste furono principalmente slavi considerati collaboratori dello stato italiano e del regime fascista. La prima reazione delle autorità portò nell’ottobre del 1929 alla fucilazione a Pola del croato Vladimir Gortan ed a pesanti condanne per quattro suoi compagni.
Particolare clamore suscitò l’attentato al “Popolo di Trieste” del febbraio 1930, in cui rimase ucciso un redattore. L’organizzazione venne distrutta da una vasta azione repressiva che culminò del processo celebrato a Trieste nel settembre 1930 da parte del Tribunale speciale per la difesa dello stato, che comminò quattro condanne a morte. Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir Miloš e Alojz Valenčič furono fucilati al poligono di Basovizza. Su questo tema si rimanda al progetto "Le vie della memoria", in particolare alla scheda "I fucilati di Basovizza".
Il movimento clandestino si riformò negli anni successivi, questa volta anche con l’appoggio del partito comunista d’Italia. Alla fine degli anni ’30, quando cominciarono a spirare venti di guerra, il TIGR iniziò a collaborare, oltre che con i servizi segreti jugoslavi, anche con quelli britannici. L’organizzazione fu definitivamente smantellata nel 1941. Nel dicembre il secondo processo del Tribunale speciale a Trieste comminò nove condanne a morte, di cui cinque eseguite: Pinko Tomažič, Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos e Ivan Vadnal, fucilati al poligono di Opicina.
L'espressione «pulizia etnica» è entrata nell'uso comune negli anni ’90 del XX secolo, diffusa dai mass-media, che hanno tradotto l'espressione serbocroata etničko čišćenje usata dai mass-media locali in riferimento ai massacri in corso durante le guerre jugoslave. Il termine “pulizia” richiama un campo semantico assai diffuso nel linguaggio della biopolitica del ‘900 (le “pulizie” naziste dagli ebrei, le “purghe” staliniane) che rimandano ad una concezione della comunità come organismo vivente che va depurato dagli elementi infetti (su base etnica, razziale, di classe). Il termine “etnico” rimanda invece alla concezione etnicista della nazione adottata dai movimenti nazionali slavi. Pertanto, tale aggettivo non può venir applicato a comunità nazionali che si definiscono su basi non etniche, come gli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia. In tali casi è preferibile far riferimento ai processi di “semplificazione nazionale” che hanno interessato tutta l’Europa centro-orientale nel ‘900.
Negazionismo/Riduzionismo/Giustificazionismo
Si tratta di termini molto diffusi, non sempre a proposito.
Nell’ambito storico, per Negazionismo s’intende l’atteggiamento di negazione pregiudiziale di eventi la cui realtà è considerata inaccettabile alla luce delle proprie convinzioni. Il termine è normalmente riferito alla Shoah e ad altri genocidi. Fermo restando che nelle terre adriatiche fenomeni di tipo genocidario non ve furono – se non appunto le ricadute locali della Shoah – alcuni aspetti dell’approccio negazionista sono stati applicati anche ad altre vicende, quali le foibe (qui intese come stragi) e l’esodo (qui inteso quale spostamento forzato di una popolazione autoctona), tanto da presentarli quali meri frutti della propaganda italiana. Tale approccio consiste nell’adozione di un metodo ipercritico che, partendo dalla normale critica delle fonti, finisce per negare credibilità a tutte quelle che contraddicono l’interpretazione preferita. Spesso il negazionismo parte dall’individuazione di errori puntuali effettivamente presenti nelle testimonianze, per inficiarne la validità complessiva; ovvero, muove dalla denuncia di esagerazioni, deformazioni, manipolazioni e strumentalizzazioni compiute nella presentazione dei fatti, per giungere a smentire l’esistenza degli avvenimenti stessi. Ad esempio, partendo dalla critica di evidenti esagerazioni nella quantificazione delle stragi delle foibe (10, 20mila morti) si può in tal modo arrivare a negare che le stragi siano effettivamente avvenute. Altre tecniche consistono nel mettere in dubbio la credibilità dei testimoni in base alle loro appartenenze e/o nel decontestualizzare le testimonianze.
Quella di Riduzionismo è una categoria dai contorni più sfuggenti. In termini generali, può riguardare il tentativo di ridurre artificiosamente la portata di fenomeni sgraditi, operando vuoi sul piano numerico che su quello del loro significato. Nel primo caso, tipica è l’adozione di stime le più basse possibili quando si tratta di quantificare le vittime di stragi, deportazioni, espulsioni di massa, laddove lo stato delle fonti non consenta calcoli precisi ed incontrovertibili. Nel secondo caso, un buon esempio, relativo alle stragi delle foibe, consiste nel concentrare l’attenzione sulle motivazioni individuali delle singole uccisioni, in modo da occultare il fatto che esse facevano parte di un disegno repressivo organizzato. Per quanto riguarda l’esodo, un caso da manuale di approccio riduzionista si ha nel rifiuto di considerare le motivazioni politiche, in risposta ai comportamenti delle autorità jugoslave, come una delle componenti fondamentali del fenomeno, che viene in tal modo “ridotto” ad una normale migrazione economica ovvero alla conseguenza della propaganda italiana.
Di fatto riduzionista, anche se contro le intenzioni di chi la usa, è la definizione di "pulizia etnica" riferita all'esodo dei giuliano - dalmati. Infatti il fenomeno non riguardo' solo i cittadini di origine etnica italica, ma tutti quelli di sentimenti italiani.
Spesso al riduzionismo si accompagna un atteggiamento giustificazionista, rispetto al quale è necessario un chiarimento di fondo. E’ assolutamente normale ed assai utile, nella ricerca e nella ricostruzione storica, assumere i punti di vista dei diversi attori, in modo da capire meglio le motivazioni e le logiche che li hanno mossi. Comprendere, ovviamente, non significa affatto di per sé giustificare: ad esempio, studiare dall’interno i meccanismi che resero possibile la Shoah non significa essere nazisti e, allo stesso modo, analizzare dall’interno i presupposti, gli obiettivi e i metodi dell’ondata repressiva del maggio 1945 nella Venezia Giulia, non vuol dire affatto condividerli. Giustificazionismo invece vuol dire immedesimarsi nella visione di uno dei soggetti storici, al punto da approvare senza riserve tutte le sue azioni. Una tipica lettura giustificazionista è quella che vede nelle foibe soltanto una legittima reazione alle violenze fasciste e/o un’altrettanto legittima violenza rivoluzionaria contro i nemici di classe. Nella medesima direzione va il tentativo compiuto in sede interpretativa, di rovesciare sulle vittime l’onere della prova della loro innocenza, così come avveniva nei procedimenti sommari.
Grande attenzione peraltro, va posta a non considerare semplicisticamente come negazionismo/riduzionismo/giustificazionismo, tutti gli atteggiamenti di critica nei confronti di interpretazioni consolidate, specie se queste sono maturate nell’ambito polemico-politico piuttosto che scientifico, perché la messa in discussione delle precedenti letture del passato rientra nella normale pratica della ricerca, così come la presa di distanza dalle semplificazioni diffuse nell’uso pubblico della storia..
Fascismo di confine (ideologia)
«Fascismo di confine» è la definizione che il nuovo movimento (trasformatosi poi in partito) scelse fin dal 1919 per sottolineare la sua specifica identità in relazione alla realtà locale (il Friuli e soprattutto la Venezia Giulia) e nazionale. Si delineò molto velocemente l’immagine e il mito del confine come «barriera» invalicabile e, nello stesso tempo, come bastione da cui proiettarsi verso l’Europa Sud – Orientale, segnatamente verso il Regno dei serbi, croati e sloveni (SHS), appena sorto. A Trieste fu precoce, rispetto ad altre zone d’Italia, la nascita del fascio (3 aprile del 1919) e fu presto organizzata la sua violenta forza d’urto. Alle sue origini vi era un insieme disordinato di gruppi diversi e di idee non ben delineate: dalle urla rabbiose contro la «vittoria mutilata», al grido di vendetta per i troppi morti e le troppe sofferenze provocate dalla guerra, alle promesse di giustizia sociale e di rinnovamento politico contro le istituzioni rappresentative e associative della fragile democrazia liberale. Un forte nesso di aggregazione venne costituito da alcuni precisi elementi: il nemico esterno, gli «slavi» del Regno SHS; il nemico interno e cioè gli «slavi» presenti nell’area, contro cui la tradizione nazionalista si era ben allenata nel passato; l’evidente incapacità delle nuove autorità italiane (salvo rare e deboli eccezioni) di capire in quale mondo fossero state delegate a governare. Il movimento di ribellione sociale guidato dai sindacati e dal partito socialista si presentava, a sua volta, come il primo contendente dello scontro diretto e violento che si aprì nelle piazze e nei quartieri operai.
Fascismo di confine (squadrismo)
A Trieste «le squadre volontarie di difesa cittadina» sorsero nel maggio del 1920, per raggiungere ben presto una forte potenzialità d’azione, sotto la guida di Francesco Giunta, destinato ad una importante carriera durante il ventennio fascista, ma giunto a Trieste nelle vesti di avvocato e soprattutto di ex ufficiale dell’esercito, all’interno di quegli uffici ITO (Uffici Informazioni Truppe Operanti) che ebbero un ruolo essenziale nell’orientare l’opinione delle autorità italiane sulla realtà sociale e politica dei territori appena occupati dopo il crollo dell’Impero austro ungarico.
Nel marasma del primo dopoguerra, Francesco Giunta, emulo di D’Annunzio, organizzò le squadre per combattere quella che veniva definita «l’Antinazione» (sloveni, croati e socialisti). Si trattava di circa 156 soggetti molto attivi nella sola Trieste, tenendo conto che nel 1921 la Federazione fascista di Trieste contava 14.756 iscritti. Erano uomini – ragazzi, spesso sono legati tra loro da vincoli di parentela (cugini, fratelli, padri e figli), che proiettavano la loro aggressività dalle famiglie verso l’esterno, ma che altrettanto spesso provenivano dall’esperienza fiumana e dalla disperata fuga dalle loro terre d’origine (dal Centro e dal Sud Italia) in cerca di fortuna e di lavoro. In poco tempo l’idea della «squadra» si consolidò attraverso le sanguinose spedizioni verso le campagne abitate prevalentemente da sloveni e da croati o in altre zone della regione, mentre le autorità politiche e militari rifuggivano da azioni decise di contrasto. Il legame interno era poi esibito dalla divisa comune (la camicia nera), dal cameratismo audace che evocava il ricordo della guerra e da atteggiamenti e comportamenti che rifiutavano l’immagine dell’uomo disorientato e ferito, imponendo quella del «maschio» sano e invincibile.
Il collante principale fu, tuttavia, la violenza, fonte di esaltazione e di complice ricatto. Il 13 luglio 1920, l’incendio del Narodni Dom, il più moderno e importante centro culturale delle organizzazioni slave della città, segnò il trionfo dello squadrismo fascista e del capo carismatico Francesco Giunta, che in quell’azione ripose l’essenza del fascismo di confine, mentre le autorità civili e militari rimanevano a guardare, senza opporre alcuna forma di contrasto. Nel disordine violento delle squadre, infatti, intravvedevano, la possibilità di ristabilire l’ordine che esse non erano capaci di imporre con i mezzi della tradizione liberale, mentre, al loro interno, non mancavano forme di complicità e di condivisione rispetto al nuovo soggetto politico. [Su questo tema si rimanda al progetto "Le vie della memoria" in particolare alla scheda "Il rogo del Narodni Dom"].
Nel disordine violento delle squadre, infatti, intravvedevano, la possibilità di ristabilire l’ordine che esse non erano capaci di imporre con i mezzi della tradizione liberale, mentre, al loro interno, non mancavano forme di complicità e di condivisione rispetto al nuovo soggetto politico.
Fascismo di confine (bonifica etnica)
Una delle fonti principali d’ispirazione del fascismo di confine fu senz’altro rappresentata dal nazionalismo: il tema dell’antislavismo si annidava quindi nel cuore del nuovo movimento e poi del PNF, provocando una serie di provvedimenti legislativi tendenti ad escludere una parte importante della popolazione slovena e croata della regione dalla partecipazione alla vita pubblica. L’italianizzazione dei cognomi, la riscrittura della toponomastica, la subitanea persecuzione del clero «slavo», la chiusura delle scuole slovene e croate nonché di tutte le associazioni e partiti che a quel mondo si riferivano, rappresentavano tuttavia solo una parte (certo la più vistosa) di scelte di snazionalizzazione, che crearono divisioni profonde all’interno di una comunità che, nonostante gli attacchi del nazionalismo del primo Novecento, aveva trovato forme di mediazione significative: matrimoni misti, affari in comune, mescolanze culturali non erano affatto fenomeni rari. Il fascismo di confine, anche attraverso provvedimenti di polizia molto pesanti (la vigilanza puntigliosa, le denunce, il confino, il deferimento presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato), tentò di cancellare l’identità di coloro che venivano considerati, secondo una definizione ricorrente, «gli infedeli»: il regime fascista, non diversamente di quanto accade per il resto della popolazione italiana, chiedeva loro supina obbedienza. Nel caso degli sloveni e dei croati presenti nell’area era tuttavia incombente la minaccia di essere accusati di terrorismo, sostenuto dal nemico slavo al confine. La propaganda e il disprezzo verso la popolazione slovena e croata, considerata di civiltà inferiore, si univa spesso a forme di allettamento soprattutto sul piano dell’assistenza verso i più disagiati. Il totalitarismo fascista, puntando alla ridefinizione del corpo nazionale sotto le sue esclusive insegne, seguì, infatti, molte strade: l’adescamento (e la «conversione») «dei diversi» fu una di queste.
Che l’operazione di «bonifica etnica» fosse riuscita non si può dire, poiché la popolazione, nelle chiese e nelle case, continuò in buona misura a preservare la propria identità, opponendo una resistenza tenace che spesso si trasformava in aperta opposizione antifascista. «Brutale e fiacca» è stata definita quella scelta di snazionalizzazione tanto esaltata dalla propaganda: un censimento riservato del 1939 per tutta la Venezia Giulia, impostato secondo i criteri della lingua d’uso, mostrò alle autorità competenti la solidità della presenza «allogena», ben poco scalfita, rispetto al 1921, nella sua consistenza numerica (circa 395.000 alloglotti presenti su una popolazione di un 1.000.000 unità), nonostante anche una forte emigrazione (molte decina di miglia di unità, stime più precise sono impossibili). Tuttavia, il gioco mortale innescato dal disprezzo e dall’odio che si colora di razzismo non avrà termine. A lungo, anche dopo la caduta del fascismo, sarà destinato a lacerare le terre di confine.
OCCUPAZIONI ITALIANE IN JUGOSLAVIA
A seguito dell’aggressione alla Jugoslavia dell’aprile 1941 da parte delle truppe dell’Asse, seguita da una rapida vittoria tedesca, il Paese balcanico venne diviso fra i vincitori. La Serbia rimase formalmente indipendente sotto controllo germanico, ma grandemente ridimensionata, avendo perso territori a favore dell’Ungheria e della Bulgaria. La Croazia venne costituita in stato indipendente, retto dal regime fascista degli ustascia (già movimento terrorista finanziato dall’Italia) con a capo Ante Pavelić; comprendeva anche la Bosnia-Erzegovina, ma non la Dalmazia, annessa all’Italia. Il Montenegro venne staccato dalla Serbia, perse il Kossovo a vantaggio dell’Albania e venne controllato dall’Italia. La Slovenia perse alcuni territori a vantaggio dell’Ungheria e venne divisa fra la Germania e l’Italia (provincia di Lubiana).
La Croazia era considerata uno stato alleato della Germania e dell’Italia, ma il suo territorio rimase occupato sia da tedeschi che italiani, per garantire l’ordine pubblico. Infatti, la dura politica antiserba del regime scatenò la ribellione armata dei serbi. Inoltre, dopo l’attacco tedesco all’Unione Sovietica del 1941, in quasi tutta la ex Jugoslavia cominciò ad agire un movimento partigiano a guida comunista.
Nei territori occupati le truppe italiane tennero comportamenti contradittori. In genere protessero la popolazione serba là dove essa era minacciata dalle persecuzioni ustascia. Inoltre, si rifiutarono di consegnare gli ebrei ai tedeschi e li posero al sicuro sull’isola dalmata di Arbe.
Invece, nelle zone in cui era attivo il movimento partigiano adottarono pratiche repressive estreme. Gli ordini impartiti, fra cui la circolare 3C del generale Roatta del marzo 1942, configuravano una vera e propria «guerra ai civili». Le azioni antiguerriglia prevedevano arresti, prese di ostaggi, fucilazione degli ostaggi medesimi, distruzione dei paesi, uccisione degli uomini e deportazione di donne e bambini. In particolare, nelle zone in cui l’esercito italiano non riusciva a venire a capo della ribellione, provvide a svuotare il territorio con la deportazione in massa della popolazione.
I deportati furono alcune decine di migliaia, reclusi in un gran numero di campi collocati sulle isole dalmate e nella penisola italiana. I più famigerati furono quelli di Gonars in Friuli e dell’isola di Arbe. Qui la mortalità fu assai elevata per le pessime condizioni igieniche ed abitative e la sistematica sottonutrizione.
A partire dal 1942 le azioni partigiane cominciarono ad interessare anche le province giuliane di Fiume, Trieste e Gorizia. Anche qui pertanto le autorità italiane adottarono le medesime pratiche repressive. Va segnalata ad esempio la strage compiuta nel luglio 1942 nel paese di Podhum, nei pressi di Fiume, in cui vennero uccisa una novantina di persone, cioè tutti i maschi adulti del villaggio. Sempre nel 1942 venne costituito l’Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, specificatamente dedicato alla lotta antipartigiana mediante l’infiltrazione e la tortura.
Termine utilizzato dalle popolazioni di lingua italiana derivante dal latino fovea (fossa, buca, ma anche antro e spelonca). Indica profonde cavità carsiche con ingresso verticale, a pozzo. Il termine speleologico equivalente è “abisso”. L’imboccatura può essere larga da pochi decimetri a parecchi metri e il pozzo può sprofondare per alcune decine di metri, anche con più salti. Un esempio tipico è la “Grotta Plutone” (59/23VG), che ha un pozzo d’accesso profondo 112 m con l’imboccatura di circa 10 metri di diametro. Nel solo Carso triestino e goriziano si trovano più di un centinaio di cavità di questo tipo e numerose altre si aprono nei terreni carsici in Slovenia e Croazia.
Storicamente, le foibe sono state utilizzate episodicamente come depositi di materiali di scarto. Durante la seconda guerra mondiale ed il dopoguerra, sono state intensivamente adoperate per far sparire i cadaveri di caduti in combattimento e/o vittime di eccidi, data la difficoltà di scavare fosse comuni nel terreno roccioso. Tale uso in Croazia è attestato fin dal 1941. Nella Venezia Giulia sono state adoperate allo stesso modo nell’autunno del 1943 (particolarmente nota la foiba di Vines, in Istria) e nella primavera/estate del 1945 (note la foiba Plutone, vicino Trieste; le foibe di Gargaro e Zavni in provincia di Gorizia; la foiba di Costrena nei pressi di Fiume).
Medesimo utilizzo hanno avuto cavità minerarie, con le quali spesso le foibe vengono confuse nel linguaggio corrente. Particolarmente note sono la Huda Jama nella zona di Laško in Slovenia e nella Venezia Giulia il pozzo della miniera di Basovizza, solitamente chiamato foiba di Basovizza.
In realtà non si tratta di una foiba (abisso carsico), bensì di una cavità mineraria (pozzo della miniera), di grandi dimensioni (larga una decina di metri, profonda più di 250). Nella prima decade di maggio del 1945 venne probabilmente utilizzata per gettarvi le salme di diverse centinaia di prigionieri italiani fucilati nei pressi. Testimonianze concordi parlano dei processi sommari tenuti nell’arco di un paio di giornate a carico di alcune centinaia di uomini arrestati a Trieste, pare in massima parte membri della Questura. Ai processi seguirono le fucilazioni collettive e l’occultamento dei cadaveri nel pozzo e forse anche in alcune altre foibe vicine. Nell’abisso vennero gettati anche i resti della battaglia svoltasi pochi giorni prima nel vicino paese di Basovizza, alle porte di Trieste, fra truppe tedesche e jugoslave, nonché altri materiali. [Su questo tema si rimanda al progetto "Le vie della memoria" in particolare alla scheda "La foiba di Basovizza"].
I recuperi delle salme tentati dalle autorità anglo-americane non ebbero esito, per difficoltà tecniche legate soprattutto alla presenza di munizioni inesplose. In assenza di riscontri obiettivi, ancora nell’estate del 1945 un giornalista italiano, considerata la massa di detriti presenti nel pozzo, la cui profondità era nota, ipotizzò che entro la foiba avrebbero potuto trovare posto fino a 1.500 cadaveri. Una simile ipotesi, da parte dei media del tempo e nell’ambito della lotta politica assai vivace in quegli anni, si trasformò ben presto nell’affermazione che a Basovizza erano stati infoibati 1.500 italiani. Tale convinzione si è poi consolidata nella memoria e nell’uso pubblico e viene ancor oggi spesso ripetuta senza alcun vaglio critico.
Il pozzo della miniera di Basovizza è divenuto nel tempo il luogo simbolo di tutte le foibe. Costituisce a tutt’oggi la sede privilegiata di cerimonie commemorative e patriottiche. Utilizzato negli anni ’50 come discarica di materiali inerti, è stato successivamente chiuso con una lastra di pietra, proclamato nel 1992 monumento nazionale e nel 2007 oggetto di un nuovo intervento di monumentalizzazione, che ha comportato anche la realizzazione di un centro visite.
Termine correntemente usato per indicare le stragi dell’autunno 1943 in Istria e del maggio 1945 in tutta la Venezia Giulia per opera del movimento di liberazione jugoslavo (autunno 1943) e dello stato jugoslavo (primavera 1945), occasioni nelle quali i corpi delle vittime vennero spesso gettati nelle foibe, di solito dopo fucilazione collettiva. L’uso di tale terminologia può essere fonte di equivoci. Molte delle vittime infatti non furono uccise subito dopo l’arresto, ma condotte in prigionia e morirono nei campi, per gli stenti e le angherie. Di molti altri arrestati si è persa ogni traccia rimasero nella categoria dei dispersi (ma non degli infoibati veri e propri). Non vi è quindi alcuna corrispondenza fra il numero degli esumati (gli infoibati veri e propri) e quello complessivo delle vittime.
Definizione correntemente usata per indicare le stragi dell’autunno 1943 in Istria. Dopo la capitolazione italiana dell’8 settembre, per poco più di un mese la penisola istriana cadde per la maggior parte sotto il controllo del movimento di liberazione croato (jugoslavo), che vi applicò le pratiche di lotta correntemente adottate nel corso della lotta di liberazione / guerra civile / rivoluzione in Jugoslavia. Tali pratiche prevedevano nelle zone anche solo temporaneamente liberate, l’immediata eliminazione dei «nemici del popolo». Questa era una categoria di origine bolscevica e staliniana estremamente flessibile, che nel caso dell’Istria riguardava alcuni segmenti di classe dirigente italiana particolarmente invisi ai partigiani, per il loro ruolo svolto nel regime fascista (gerarchi, squadristi), nelle istituzioni (podestà, segretari comunali) e nella società locale (possidenti terrieri, commercianti ed artigiani accusati di strozzinaggio) o comunque ritenuti pericolosi per il nuovo potere.
Le nuove autorità organizzarono gli arresti, la concentrazione dei prigionieri in alcune località specifiche, come Pisino, i processi sommari e le conseguenti fucilazioni collettive, seguite dall’occultamento dei cadaveri nelle foibe o in cavità minerarie. Si trattò quindi di una violenza dall’alto, programmata e gestita dai quadri del movimento di liberazione croato (jugoslavo). Peraltro, essa fu gestita in un clima di grande confusione, segnato da forme di ribellismo dei contadini croati, nel quale trovarono spazio estremismo nazionale, conflitti d’interesse locali, motivazioni personali e criminali, come nel caso di alcuni stupri seguiti da uccisioni, fra i quali assai noto quello di Norma Cossetto.
Definizione correntemente usata per indicare le stragi del maggio 1945 nella Venezia Giulia. Dopo il 1o maggio tutta la regione venne occupata dalle truppe jugoslave, che vi rimasero fino al 9 giugno, data dopo la quale si ritirarono ad est della linea Morgan, mentre ad ovest della linea medesima fu instaurata un’amministrazione militare anglo-americana. Durante l’occupazione si verificò l’estensione alla Venezia Giulia delle pratiche repressive tipiche della presa del potere in Jugoslavia da parte del fronte di liberazione a guida comunista. [Su questo tema si rimanda al progetto "Le vie della memoria" in particolare alla scheda "L'eccidio di via Imbriani"]. Tale presa del potere fu accompagnata da una grande ondata di violenza politica, che nell’arco di poche centinaia di chilometri fra l’Isonzo, la Slovenia e la Croazia fece circa 9.000 morti fra gli sloveni domobranzi, almeno 60.000 fra i croati ustascia ed alcune migliaia fra gli italiani.
Si trattava chiaramente di violenza di stato, programmata dai vertici del potere politico jugoslavo fin dall’autunno del 1944, organizzata e gestita da organi dello stato (in particolare dall’Ozna, la polizia politica). Sta in questo la sua differenza sostanziale con l’ondata di violenza politica del dopoguerra nell’Italia settentrionale. Quest’ultima infatti può venir interpretata come resa dei conti di una guerra civile iniziata negli anni ’20 ed anche come tentativo di alcuni segmenti del partigianato comunista di influire sui termini della lotta politica in Italia, ma non era inserita in alcun disegno strategico di natura rivoluzionaria, perché il PCI in Italia non doveva fare la rivoluzione. Viceversa, nella Venezia Giulia come nel resto della Jugoslavia, quella violenza era strumento fondamentale per il successo della rivoluzione ed il consolidamento del nuovo regime.
Nei territori adriatici quindi lo stragismo aveva finalità punitive nei confronti di chi era accusato di crimini contro i popoli sloveno e croato (quadri fascisti, uomini degli apparati di sicurezza e delle istituzioni italiane, ex squadristi, collaboratori dei tedeschi); aveva finalità epurative dei soggetti ritenuti pericolosi, come ad esempio gli antifascisti italiani contrari all’annessione alla Jugoslavia (membri dei CLN, combattenti delle formazioni partigiane italiane che rifiutavano di porsi agli ordini dei comandi sloveni, autonomisti fiumani); ed aveva finalità intimidatorie nei confronti della popolazione locale, per dissuaderla dall’opporsi al nuovo ordine. Anche in questo caso vi furono infiltrazioni di criminalità comune, come nel caso della foiba Plutone.
Sorte simile a quella degli arrestati civili ebbero i militari della RSI. Dopo la resa i reparti vennero in genere sottoposti a decimazioni selvagge. Poi i prigionieri vennero inviati ai campi dove trovarono condizioni spaventose, per la denutrizione ed i maltrattamenti. Particolarmente noto è al riguardo il caso del campo di Borovnica (pron. Borovnizza) presso Lubiana, dove la mortalità fu assai elevata.
Per le stragi del 1943 l’ordine di grandezza è delle centinaia (le stime variano da 500 a 700). Per le stragi del 1945 l’ordine di grandezza è delle migliaia. Lo stato della ricerca non consente quantificazioni precise. Gli arrestati nelle province di Trieste e Gorizia furono circa 10.000, ma la maggior parte di essi fu liberata nel corso di alcuni anni. Secondo una ricerca condotta a fine anni '50 dall'Istituto centrale di statistica, le vittime civili (infoibati e scomparsi) nel 1945 dalle province di Trieste, Gorizia ed Udine furono 2.627. Probabilmente la cifra è leggermente sovrastimata, perché qualche prigioniero può essere rientrato senza darne notizia. D'altra parte, a tale stima vanno aggiunte le circa 500 vittime accertate per Fiume e qualche centinaio dalla provincia di Pola. Inoltre, mancano dal computo i militari della RSI, per i quali il calcolo è difficilissimo, in quanto le fonti non li distinguono dagli altri prigionieri di guerra. Una stima complessiva delle vittime fra le 3.000 e le 4.000 sembra perciò abbastanza ragionevole. Cifre molto superiori (10.000 o più) sono sicuramente frutto di errori, volute leggerezze metodologiche (come il computo di presunte migliaia di vittime nel pozzo della miniera di Basovizza o nella foiba 147 del Carso triestino), ovvero intenti propagandistici.
Foibe del 1945 (giudizio contenuto nel Rapporto finale della Commissione storico-culturale italo-slovena, non riguarda quindi l'Istria)
«L'estensione del controllo jugoslavo dalle aree già precedentemente liberate dal movimento partigiano fino a tutto il territorio della Venezia Giulia fu salutata con grande entusiasmo dalla maggioranza degli sloveni e dagli italiani favorevoli alla Jugoslavia. Per gli sloveni si trattò di una duplice liberazione, dagli occupatori tedeschi e dallo Stato italiano. Al contrario, i giuliani favorevoli all'Italia considerarono l'occupazione jugoslava come il momento più buio della loro storia, anche perché essa si accompagnò nella zona di Trieste, nel Goriziano e nel Capodistriano ad un'ondata di violenza che trovò espressione nell'arresto di molte migliaia di persone, - in larga maggioranza italiane, ma anche slovene contrarie al progetto politico comunista jugoslavo -, parte delle quali vennero a più riprese rilasciate; in centinaia di esecuzioni sommarie immediate - le cui vittime vennero in genere gettate nelle "foibe"; nella deportazione di un gran numero di militari e civili, parte dei quali perì di stenti o venne liquidata nel corso dei trasferimenti, nelle carceri e nei campi di prigionia (fra i quali va ricordato quello di Borovnica), creati in diverse zone della Jugoslavia.
Tali avvenimenti si verificarono in un clima di resa dei conti per la vio-lenza fascista e di guerra ed appaiono in larga misura il frutto di un pro-getto politico preordinato, in cui confluivano diverse spinte: l'impegno ad eliminare soggetti e strutture ricollegabili (anche al di là delle responsabilità personali) al fascismo, alla dominazione nazista, al collaborazionismo ed allo stato italiano, assieme ad un disegno di epurazione preventiva di oppositori reali, potenziali o presunti tali, in funzione dell'avvento del regime comunista, e dell'annessione della Venezia Giulia al nuovo Stato jugoslavo. L'impulso primo della repressione partì da un movimento rivoluzionario che si stava trasformando in regime, con-vertendo quindi in violenza di Stato l'animosità nazionale ed ideologica diffusa nei quadri partigiani».
Letteralmente, gettati nelle foibe. Simbolicamente, tutte le vittime delle stragi dell’autunno 1943 e della primavera 1945. L’uso simbolico, per quanto assai diffuso, può dar luogo a fraintendimenti. In primo luogo, va precisato che l’infoibamento non era una modalità di uccisione, ma di occultamento delle salme, legato in genere alla difficoltà nello scavo di fosse comuni. Risultano pochissimi casi in cui nell’abisso furono gettate persone ancora vive, specie per errori nella fucilazione. In secondo luogo, non tutte le vittime delle stragi conclusero la loro vita nelle foibe. Molti, forse la maggior parte, trovarono la morte in prigionia. Un uso non accorto del termine infoibati può dar luogo quindi a contestazioni ed equivoci sulla quantificazione delle vittime. Più corretto sarebbe parlare di uccisi e dispersi.
Per esodi nella letteratura scientifica (Ferrara e Pianciola) si intendono "quei casi in cui un gruppo di abitanti fu indotto a fuoriuscire dai confini politici del territorio in cui viveva a causa di pressioni esercitate dal governo che lo controllava, sia in termini di violenza diretta sia in termini di privazione di diritti, soprattutto in corrispondenza di un radicale mutamento politico che investiva le relazioni tra stati (conflitti bellici, crolli e costruzioni di stati). In tali circostanze la migrazione forzata non era il chiaro obiettivo iniziale del governo in questione, né tantomeno quest’ultimo la organizzò; il risultato finale fu comunque l’emigrazione quasi totale del gruppo. Questi casi vanno senza dubbio compresi nel novero delle migrazioni forzate, anche se furono gli unici in cui la scelta di migrare fatta dai singoli o dalle singole famiglie ma estesasi fino ad acquisire una dimensione di massa, ebbe un ruolo attivo nello spostamento. Essi furono inoltre gli unici in cui le condizioni di arrivo (per esempio la concessione della cittadinanza nel paese di accoglienza) furono un fattore importante».
L’esodo quindi è un particolare tipo di spostamento forzato di popolazione, diverso nelle modalità di attuazione rispetto alla deportazione ovvero all’espulsione, ma che giunge al medesimo risultato. La scelta degli italiani di Fiume e dell’Istria di optare per la cittadinanza italiana (come previsto dal trattato di pace) trasferendosi nella Penisola, non può dunque essere considerata una decisione libera da costrizioni.
Esodo dei giuliano dalmati (ondate)
L’esodo non fu un evento unico ma un processo di abbandono lungo l’arco cronologico 1943-1956. I distacchi furono diversificati per motivazioni e tempistiche, ma accomunati dall’esito: il crollo della popolazione italiana nei suoi insediamenti storici. L’esodo da Zara fu il primo in ordine cronologico: iniziato già nel 1941 con una prima ondata di 10.000 partenze, proseguì nel 1942, al ritmo delle devastanti incursioni aeree alleate; si intensificò con l'ingresso delle truppe jugoslave nell'ottobre 1944, per concludersi nei primi anni ’50: nell’intero periodo la città perse il 70% della popolazione residente nel 1942, circa 43.670 persone (vittime incluse).
Nei primi giorni del maggio 1945, entrarono le truppe vittoriose dell’esercito jugoslavo a Trieste e Pola il 1 maggio, il 3 Fiume. All’occupazione fece seguito l’insediamento dei Comitati popolari di liberazione e dei Tribunali del popolo, incaricati di sommarie epurazioni. A Fiume iniziava l’esodo per più di 20.000 italiani, entro il gennaio 1946, parte di un totale di circa 36.000 abbandoni.
A Pola, nel luglio 1946, su 31.700 residenti, 28.058 dichiararono di voler lasciare la città in caso di definitiva cessione alla Jugoslavia. La strage di Vergarolla del 18 agosto (l’esplosione dolosa di una ventina di bombe posizionate sulla spiaggia fece 65 vittime e una quarantina di feriti) fu vissuta dalla popolazione come strategia terroristica jugoslava per mettere in fuga gli italiani. A dicembre si aprì un movimento di massa che coinvolse circa 30.000 persone. Ai residenti nella città si aggiunsero infatti migliaia di istriani lì confluiti per prender posto sui piroscafi messi a disposizione dal Comitato esodo dal Governo italiano. Le immagini dell’imbarco sul piroscafo Toscana in quel gelido inverno sarebbero divenute icona di tutto il movimento dell’esodo. Una città desertificata passò formalmente alla sovranità jugoslava il 15 settembre 1947.
Con il Trattato di pace e la conseguente apertura del diritto di opzione, gli esodi legali costituirono la maggior parte del flusso migratorio; prima (dal 1943) se n’erano andate circa 80.000 persone, in prevalenza dalla Dalmazia e da Fiume. A seguito del Trattato di pace, nel 1947 abbandonarono l'Istria e il goriziano circa 50.000 persone; nell’anno successivo gli optanti giuliano-dalmati furono circa 80.000. Mentre i maggiori dai centri urbani dei territori ceduti – Zara, Fiume, Pola – furono abbandonati dalla popolazione in modo concitato e plebiscitario, le partenze dalle campagne procedettero in tempi più lunghi.
Tra gennaio e aprile 1951, la riapertura dei termini per opzioni consentì l’espatrio 6.580 persone. Dopo, chi voleva abbandonare la Jugoslavia poté farlo solo attraverso l’onerosa procedura dello «svincolo», che interessò 5.238 soggetti.
Nei distretti di Capodistria e Buie, parte della zona B del TLT, provvisoriamente amministrati dall’autorità militare jugoslava (VUJA), le partenze ebbero una prima impennata nel 1950 (un migliaio) in relazione con le violenze che si verificarono in occasione delle elezioni amministrative del 16 aprile. Prima della nota bipartita di Stati Uniti e Gran Bretagna - con la quale si annunciava la volontà di ritiro dalla zona A per affidarne l'amministrazione al Governo italiano (8.10.1953) - risultava avessero lasciato la zona B già 17.000 persone.
Con il Memorandum d’intesa finìva l’amministrazione militare delle due zone del TLT e la linea di demarcazione venne di poco modificata a favore della Jugoslavia, concedendole parte del territorio del comune di Muggia, dal quale 2.748 abitanti su 3.492 decisero di trasferirsi in Italia. Iniziò il "grande esodo dalla zona B» che si concluse ufficialmente nella primavera 1956, con circa 40.000 partenze, pari ai 2\3 della popolazione.
Le stime più attuali indicano un flusso complessivo di 280.000- 300.000 anime, di cui 201.440 i nominativi censiti all’epoca dall’ l'Opera di Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati. Risulta tuttora arduo distinguere nelle cifre complessive univoche definizioni nazionali, in un territorio con estese aree di ibridismo, incerti processi di nazionalizzazione e appartenenze vissute come «atto di elezione».
Cifre piuttosto attendibili propongono 243 mila persone escludendo i non nativi, 279 mila escludendo solo le persone dell’entroterra del goriziano, triestino e fiumano, 301 mila comprendendo tutti, di cui è ipotizzabile un 15% di croati e sloveni. Secondo il censimento jugoslavo del 1961, comprendente anche la Zona B, nei territori annessi permaneva solo un 44% della popolazione residente nell’anteguerra (186.450), se n’era andato più del 55% (232.994), erano giunte 144.505 nuove presenze a seguito delle politiche migratorie avviate dal governo jugoslavo dopo le partenze degli italiani.
Esodo dei giuliano dalmati (motivazioni)
Nonostante il binomio foibe-esodo si sia saldato nel senso storico comune, diventando la più popolare chiave interpretativa del fenomeno, l’indagine storico sociale ha da tempo evidenziato un’ampia gamma di accadimenti e motivazioni.
Certamente le foibe istriane nell’autunno del 1943 gettarono il seme della paura e continuarono a rappresentare la mancanza di tutela cui la popolazione italiana si sentiva esposta. Con la densità propria degli archetipi, la «foiba» esprimeva l'angoscia per il ribaltamento delle gerarchie, l’avversione per un potere arbitrario ma non tanto autorevole da esibire le sue condanne, la paura dell'annullamento individuale, comunitario, nazionale.
A partire dal 1945, una persistente conflittualità con i Poteri popolari venne vissuta in ogni ambito dell’agire quotidiano, sui fronti delle confische (abitazioni, botteghe, officine, proprietà agricole, strumenti di produzione, tecnologie anche minime) delle collettivizzazioni, dei rifornimenti di beni di prima necessità, delle politiche culturali, scolastiche e religiose, della formazione dei giovani, del lavoro volontario e coatto.
I maggiori picchi di violenza si ebbero con la visita in Istria di una commissione interalleata, incaricata di studiare la futura linea di confine (1946), con l’apertura delle prime e delle seconde opzioni (1948-1951), la repressione anticominformista (dal 1948), le elezioni del 1950, le manifestazioni contro l’Italia del 1953-1954. Le «pressioni ambientali» furono però costanti e comportarono una percezione del pericolo anche per coloro che non furono vittime di maltrattamenti, ma consapevoli di vivere entro una società militarizzata e governata da polizie segrete.
Diversi potevano essere i livelli di intimidazione, violazione dei diritti e repressione vera e propria: dai licenziamenti, sfratti, reclutamenti forzosi, alle bastonature, carcerazioni, torture, sparizioni. Controllo e vigilanza si insinuavano in tutti i segmenti della società attraverso una rete di delatori capace di minare consolidati vincoli di amicizia e parentela. I più esposti a tale condizione paiono esser stati i ceti urbani, «borghesi» e operai, impegnati in un’insistente mobilitazione, più controllati sotto il profilo dell’opzione filo-jugoslava, più ricattabili in riferimento alla qualità e alla stabilità dell’occupazione. Buona parte di un mondo contadino fatto di piccoli proprietari, opponeva resistenza ad una politica agraria che sembrava ignorare le precedenti culture materiali e voler estendere il sistema di fabbrica all’agricoltura. Le nuove condizioni di lavoro nelle campagne risultavano semplicemente incomprensibili per gli anziani, ma poco attraenti anche per i giovani, esposti alle continue chiamate al lavoro volontario o all’arruolamento. La loro partenza destabilizzava le organizzazioni produttive tradizionali e in linea generale non era sostenibile per delle economie familiari di sussistenza.
Nella desolata miseria del dopoguerra istriano, a fronte di una pianificazione economica che evidenziava forti incongruenze, progressivamente venivano cancellati i tradizionali punti di riferimento – possidenti, funzionari dello stato, insegnanti, sacerdoti – accelerando la disgregazione comunitaria. Le prassi di snazionalizzazione introdotte con la slavizzazione del cognome, la chiusura di scuole e circoli, imponevano di apprendere una nuova lingua e di inserirsi in un universo culturale sconosciuto. La ruralizzazione dei centri storici pareva indicare una rivincita della campagna slava sull’urbanesimo italiano, mentre anche il proletariato avvertiva il tramonto di una particolare civiltà che aveva saputo abbinare le culture contadine con le identità cittadine, parlare le lingue dell’industria, della marineria e del commercio. L’intolleranza religiosa, già prima dell’annessione, si manifestò con varie forme di ostilità verso le consuetudini religiose popolari; il clero italiano e croato fu bersaglio di intimidazioni, aggressioni, arresti e uccisioni. Nella zona B a ciò si aggiunse la lo smantellamento delle attrezzature industriali, la riduzione dell’estrazione del sale, la fine della libertà degli scambi con Trieste.
In tali condizioni, l’opera di sostegno agli istro-italiani esercitata dall’CLN dell’Istria su delega del governo italiano, fallì nel suo intento di trattenimento delle comunità; caddero nel vuoto gli appelli dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume diretti a mantenere in loco i connazionali; mancò il bersaglio anche la propaganda dei Poteri popolari tesa a stigmatizzare chi se ne andava. Le stesse restrizioni nel vaglio delle domande di opzione, lungi dal sanare il crollo di consenso, alimentarono l’esasperazione e la pulsione all’abbandono divenuta ormai di massa.
Esodo dei giuliano-dalmati (strategia delle autorità)
La politica ufficiale del regime comunista jugoslavo nei confronti degli italiani fu quella della «fratellanza italo-slava». Si trattava di una politica di integrazione selettiva. In primo luogo, non si rivolgeva a tutti quelli che si consideravano italiani, ma solo agli italiani etnici, considerati minoranza nazionale legittima. Gli italiani di origine slava (anche remota) dovevano venir ricondotti alla loro nazionalità originaria. In secondo luogo, si rivolgeva solo agli italiani «onesti e buoni», cioè quelli disposti a mobilitarsi per l’annessione alla Jugoslavia e la costruzione del socialismo. Gli altri erano considerati «residui del fascismo», «imperialisti», «sciovinisti» e «nemici del popolo», ai quali era riservata la repressione. In terzo luogo, aveva per interlocutore le «masse popolari», proletarie e contadine e non i «borghesi», per i quali non vi era posto in uno stato socialista.
La politica della «fratellanza» quindi era limitata ad una minoranza della componente italiana, mentre la maggioranza non rientrava nei suoi parametri di accettabilità. Per di più, tale politica, elaborata dai vertici del partito, venne gestita sul campo dalla classe dirigente locale, formatasi durante la guerra di liberazione contro tedeschi ed italiani, considerati questi ultimi un tutt’uno con i fascisti. Si trattava quindi di una classe dirigente politicamente e nazionalmente estremista, propensa all’autoritarismo ed alla repressione, diffidente per principio nei confronti degli italiani e quindi del tutto inadatta a gestire una politica di mediazione.
Ne seguì una serie infinita di abusi, prevaricazioni e violenze, che colpirono duramente quanti dalla «fratellanza» erano esclusi per le ragioni più sopra indicate, ma anche individui e gruppi che potevano rientrarvi, come i ceti popolari urbani non proletari ed i piccoli coltivatori. Tutti questi soggetti, chi prima chi dopo, finirono con il ritenere il regime di Tito come un nemico da cui difendersi, perché intento a distruggere la loro identità e compromettere le loro condizioni di vita.
I limiti intrinseci alla politica della «fratellanza», sommandosi alle sue modalità di applicazione, provocarono una situazione di invivibilità, che colpì in primo luogo le comunità italiane, ma suscitò disaffezione verso il regime anche in alcuni ambienti slavi, soprattutto croati, che durante la guerra avevano attivamente sostenuto il movimento di liberazione e la lotta per l’annessione alla Jugoslavia.
Esodo dei giuliano dalmati (Opzioni)
Gli esodi legali costituirono la maggior parte del flusso migratorio e furono legati all’esercizio del diritto di opzione per la cittadinanza italiana, con il conseguente obbligo di trasferirsi in Italia: furono previsti dal trattato di pace 1947-48, dagli accordi per la riapertura nel 1951, dal Memorandum di Londra. L’accertamento del requisito fondamentale della lingua d’uso italiana era di competenza delle autorità jugoslave che inizialmente accolsero le domande di un numero limitato di persone d’indubbia origine italiana. Già nei primi mesi del 1948 venne trasformata in senso restrittivo la procedura relativa alla verifica della lingua d’uso, affidata esclusivamente agli Affari interni, quindi agli organi di polizia. Prescindendo da una libera identificazione del soggetto, si partì dal presupposto che in epoca fascista i cognomi slavi erano stati italianizzati, quindi si diffuse la pratica di restituirli all’»originaria» grafia slava, ritenendo che la gran parte delle identità percepite avesse seguito un analogo processo di ridefinizione e riscoperta di radici più lontane e autentiche. Di fatto per alcuni così avvenne, certo non per coloro che si videro negato il diritto di opzione in quanto considerati slavi, a seguito della riscrittura del cognome. In particolare nei territori ceduti già nel 1947, i richiedenti furono esposti a ritorsioni e persecuzioni, a prolungate incertezze, alla segmentazione delle parentele, indotta dall’accoglienza selettiva delle domande e dal protrarsi degli impedimenti. Le autorità jugoslave tentarono a loro modo di frenare l’esodo, in base a diversi presupposti: il timore di uno svuotamento dell’Istria e il conseguente smacco politico che ne sarebbe derivato; la convinzione che la maggior parte dell’italianità istriana fosse fittizia, frutto di processi di snazionalizzazione che andavano corretti; la necessità di mantenere le piccole e grandi professionalità possedute dagli italiani ; l’utilità di trattenere «italiani onesti», che sostanziassero le parole d’ordine della fratellanza italo-slava.
La sventurata sovrapposizione tra la questione delle opzioni - iniziate nella primavera 1948 - e la crisi del Cominform, inasprì le prassi di controllo e repressione. L’esasperata ricerca del nemico interno comportò che, nella dilatata definizione di reakcija, entrasse una pletora di presunti traditori, spioni, provocatori, sciovinisti, profittatori, opportunisti, «tentennanti», «decadenti», in definitiva tutti nemici del popolo. Il sospetto che lo strumento delle opzioni venisse usato per eludere la caccia ai cominformisti, indusse a ulteriori restrizioni, dal momento che era nota la decisa tendenza filosovietica dei comunisti italiani. Il corto-circuito che si creava tra optanti dichiarati e cominformisti sospetti indusse a un’estensione dei provvedimenti persecutori: licenziamenti, sfratti, pestaggi, lavoro coatto, colpirono prima delle retate della primavera 1949 e della messa a punto dell’arcipelago carcerario che aveva il suo centro più noto in Goli Otok. Le prassi staliniste di «conversione e rieducazione» avvennero all’interno di veri e propri gulag, come quello sulla ferrovia istriana Lupogliano-Stallie, o nelle cave di bauxite, nelle miniere carbonifere di Arsia, nella costruzione della Fužine e Skrad nel Gorski kotar. Il gruppo nazionale italiano fu colpito da più di 2.000 arresti tra il 1949 e il 1952. L’evidenza che il meccanismo delle opzioni poteva coinvolgere anche sostanziosi gruppi di croati bilingui, indusse a intervenire con «ogni sorta di misure repressive aggiuntive».
Le proteste del governo italiano fecero sì che i termini delle opzioni venissero riaperti nel gennaio-aprile 1951. Nonostante nuove illegalità e violenze, attraverso tale varco riuscirono a transitare 6.580 persone, tra le quali un forte contingente di comunisti italiani.
Esodo dei giuliano-dalmati (crisi del Cominform)
Nel giugno 1948 scoppiò la crisi che vide la rottura dei rapporti politici fra la Jugoslavia guidata da Tito e l’Unione Sovietica guidata da Stalin. La politica jugoslava fu ufficialmente condannata dal Cominform. Stalin si aspettava che gli elementi a lui favorevoli all’interno del partito comunista jugoslavo prendessero il sopravvento, ma avvenne il contrario. In tutta la Jugoslavia una feroce repressione si abbattè sui sospettati di «cominformismo». I comunisti italiani in Istria avevano inizialmente aderito al regime jugoslavo per ragioni ideologiche e non nazionali. Molti però erano rimasti delusi da quello che consideravano il «nazionalismo» dei comunisti croati ed alcuni avevano iniziato ad esodare, specie da Fiume. Fra Stalin e Tito gli italiani non ebbero dubbi a scegliere Stalin, ma così di colpo divennero anch’essi «nemici del popolo», oggetto di ogni sorta di angherie. Di conseguenza, chi non era ancora partito si unì al Grande esodo. Quando ci riuscì.
Esodo dei giuliano-dalmati (Controesodo)
Si tratta di una definizione di origine polemico-politica, ormai però entrata nell’uso pubblico e storiografico corrente, così come è avvenuto per le foibe. Per Controesodo si intende la scelta di alcune migliaia di lavoratori italiani, soprattutto operai dei cantieri di Monfalcone, di abbandonare la provincia di Gorizia restituita in Italia dopo l’entrata in vigore del Trattato di pace, per trasferirsi in Jugoslavia al fine di concorrere all’edificazione del comunismo. La maggior parte di tali lavoratori, spesso chiamati in via breve «i monfalconesi», si insediò in prevalenza a Fiume, dalla quale gli italiani autoctoni stavano esodando.
Dopo essere stati inizialmente ottimamente accolti, in quanto proletariato d’avanguardia sotto il profilo ideologico e professionale, si trovarono in grave difficoltà doppio lo scoppio della crisi del Cominform. I monfalconesi si schierarono in massa per Stalin: di conseguenza i loro principali esponenti vennero imprigionati ed avviati alla «rieducazione» nel terribile campo di Goli Otok. I rimanenti fecero ritorno in Italia, dove non furono bene accolti.
Esodo dei giuliano dalmati (accoglienza)
La prima e principale ondata di esuli, quella relativa all’esercizio del diritto di opzione dopo il Trattato di pace del 1947, non ebbe per meta principale Trieste, ancora soggetta ad amministrazione militare anglo-americana, ma la penisola italiana, anche se comunque la zona A venne interessata da numerosi arrivi, che si aggiunsero alla grande quantità di displaced persons provenienti dall’est Europa. Alla vigilia del Memorandum gli esuli a Trieste erano già oltre 30.000.
In Italia, l’accoglienza pubblica ai giuliano dalmati avvenne nel quadro di altre categorie di profughi, entro 92 strutture, dislocate in 43 città italiane, che giunsero a essere 109, nel corso degli anni ’50. La loro gestione era dipendente dal Ministero dell’Interno e dall’ Assistenza Post-Bellica, che cooperavano con le autorità comunali. Più agevole fu il trasferimento sul territorio italiano degli addetti alle Manifatture Tabacchi di Rovigno e Pola: il sistema di garanzie offerto alle maestranze consentiva infatti di seguire le piste del lavoro sicuro approdando alle aziende di Torino, Lucca, Modena, Rovereto, Venezia. Altri aiuti giunsero dal Comitato Assistenza Postbellica, emanazione del Ministero per l’assistenza postbellica – Direzione generale Alta Italia di Milano e dall’Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati. Nel 1946 venne istituito un Ufficio per la Venezia Giulia, alle dipendenze del Ministero dell’Interno ed in relazione con il «Comitato giuliano» di Roma. Sorti per fornire asilo temporaneo, molti campi divennero la residenza dei giuliano-dalmati per periodi anche lunghi, nonostante le dure condizioni di vita: temperature proibitive, mancanza di igiene, epidemie, promiscuità, frantumazione delle famiglie. Alcune migliaia di esuli non ressero un tale esperienza e presero la via dell’emigrazione in America ed Oceania. Quanto all’accoglienza da parte della società italiana, si intrecciarono gare di solidarietà ed atti di rifiuto. Questi ultimi ebbero spesso matrice politica, dal momento che la propaganda comunista dipinse gli esuli come fascisti in fuga da un paradiso socialista.
Superata la prima emergenza, autorità pubbliche e soggetti privati avviarono un’ampia gamma di iniziative a favore dei profughi. Particolare attenzione venne rivolta ai figli degli esuli dall’Opera profughi, del CLN. dell’Istria, da singoli sacerdoti, circoli di benefattori e madrine, sostenuta da una cospicua rete di sinergie, comprendente l’UNRRA, la Postbellica, la Pontificia Opera di Assistenza, il governo italiano, singoli politici e missioni internazionali. Si concretizzò nei collegi di Grado, Gorizia, Roma, Brindisi, Pesaro, Varese, Merletto di Graglia nel biellese, Volterra, San Miniato di Pisa, Fano nelle Marche, nonché in colonie e preventori.
Interventi legislativi e provvedimenti in materia di ricovero dei minori, occupazione, assegnazione di alloggi, funzionarono da acceleratore ai processi di inserimento. A partire dal 1952 era stato varato il piano di edilizia nazionale per la nascita di «borghi» giuliani in 42 città italiane, mentre a Trieste entrava in una fase operativa la costruzione di abitazioni nella cintura periferica cittadina e sul Carso (il «corridoio», ovvero la fascia di territorio che collega Trieste all’Italia). La messa in opera dei nuovi insediamenti sgretolò la compattezza del territorio etnico sloveno, alterando l’identità dei comuni carsici e provocando non poche insofferenze. Tuttavia, diverse forme di ricomposizione sociale passarono attraverso il ricambio generazionale, la scolarizzazione, i matrimoni misti, la chiesa, il mercato del lavoro e la valorizzazione economica del territorio. [Su questo tema si rimanda al progetto "Le vie della memoria" in particolare alla scheda "Il «Centro Raccolta Profughi» di Padriciano"].
L’esodo dalla Zona B fu quasi concomitante al passaggio di poteri dal GMA all’Italia, e non vi furono ostacoli all’insediamento degli istriani a Trieste e - in misura minore - a Gorizia. Nel capoluogo, una lunga consuetudine di migrazioni interne, collocò l'eccezionalità del fenomeno nel solco di una tradizione rendendolo più tollerabile. Affinità e parentele, il fatto che le parlate istriane fossero affini al dialetto locale, precedenti reti di traffici e commerci, resero la città più accogliente rispetto ad altre zone di ricezione, dove la lontananza geografica e culturale alimentava lo stereotipo dell’esule-fascista e la miseria post-bellica rendeva inconcepibile la richiesta di casa e lavoro da parte dei nuovi arrivati. Quella che da tempo era ritenuta «capitale dell’Istria», diveniva nel dopoguerra davvero la più grande città istriana.
Esodo dei giuliano dalmati (Italiani rimasti)
La permanenza degli italiani nei territori ceduti fu poco visibile e comprensibile, a lungo non menzionata dalla storiografia. I «rimasti» erano due volte minoranza: rispetto alla scelta maggioritaria dell’esodo e di fatto minoranza nazionale nella Jugoslavia di Tito. Nel ventennio post bellico parteciparono alla gigantesca opera di costruzione di uno stato socialista e ne vissero le contraddizioni: una legislazione di tutela e le perduranti discriminazioni, la piena occupazione e la costante miseria, il lavoro come slancio produttivo fonte di emancipazione e il lavoro coatto, privo di diritti.
Il primo censimento ufficiale jugoslavo (1948) per le zone dell’Istria, Fiume, Zara e le isole quarnerine, definiva la cifra provvisoria di 79.575 italiani, con esclusione della Zona B. Nella rilevazione statistica del 1961 diventavano 25.614 (compresa la ex zona B). Era cifra destinata a scendere ulteriormente: il minimo storico si raggiunse nel 1981 con circa 15.000 presenze.
La posizione della comunità nazionale italiana numericamente ridotta era ulteriormente aggravata dai dati relativi alla senescenza, dall’essere a cavallo di due repubbliche con un triplice regime: nel Capodistriano (Slovenia) e nel Buiese (Croazia) vigevano le norme dello Statuto speciale allegato al memorandum, mentre al di fuori di queste aree ridotte risultavano le forme di tutela.
Perche erano rimasti? Retroguardia nel movimento dell’esodo per la difficoltà di percorrere il labirinto delle opzioni, tanti sospesero il progetto. Altri desistettero per la concomitanza di congiunture personali: stanchezze dei reduci dalla guerra a lungo lontani dal luogo natio, pressioni e coinvolgimento nei poteri popolari, scarsa professionalizzazione, sfiducia nelle possibilità offerte dall’Italia, responsabilità plurime verso anziani e minori, forti sentimenti di appartenenza all’habitat delle origini; alcuni fecero «prove di esodo» ma la nostalgia li indusse a ritornare.
Moti di speranza nel futuro socialista coinvolsero soprattutto i giovani, formati dall’ideologia della fratellanza: rispetto ad un avvenire carico di promesse – continuamente additato - la fame e le paure, i danni e i lutti, le lacerazioni familiari e comunitarie potevano esser concepiti alla stregua di miserie private, incidenti di percorso.
Le comunità italiane si adattarono, impararono a vivere nei termini di normalità la scomparsa dei compaesani, la desertificazione dei luoghi, l’innesto di altre etnie, l’anomalia del passaggio da una condizione egemonica a quella di minoranza. Superarono un nuovo analfabetismo linguistico e politico nel quale erano piombati; impararono nuove geografie, multiculturalità e nomenclature del potere, nuovi sistemi di produzione. Lottarono per non scomparire come identità nazionale e furono comunque capaci di produrre elites culturali.
Grave e protratto fu l’isolamento rispetto alla nazione madre; per una rete strutturata di scambi con l'Italia si dovette attendere la metà degli anni Sessanta.
I luoghi di partenza, cartina realizzata da Olinto Mileta
I luoghi di arrivo e di prima accoglienza in Italia, cartina realizzata da Olinto Mileta
Con tale espressione s’intende l’avanzata concorrenziale verso Trieste da parte dell’Ottava armata britannica e della Quarta armata jugoslava nella primavera del 1945. In realtà si trattò di una corsa asimmetrica, perché la liberazione dell’Istria croata e del Litorale sloveno (territori che gli italiani chiamano Venezia Giulia) costituiva l’obiettivo principale dell’offensiva finale scatenata dalle truppe jugoslave il 4 aprile 1945, mentre l’obiettivo dell’offensiva anglo-americana era la distruzione delle truppe tedesche e la liberazione dell’Italia settentrionale. Solo alla fine di aprile, quando la seconda divisione neozelandese era arrivata fra Padova e Venezia, le fu chiesto di compiere un ultimo balzo per occupare Trieste prima degli jugoslavi. Ciò che agli alleati importava, era ottenere il controllo del porto di Trieste e delle linee di comunicazione verso l'Austria, perché unicamente in tal modo sarebbe stato possibile rifornire le truppe alleate destinate ad occupare Vienna ed il resto del paese alpino.
La corsa fu vinta dall’armata jugoslava che entrò a Trieste il 1 maggio 1945. Però gli anglo-americani, secondo la definizione di Churchill, riuscirono ad "infilare un piede nella porta», perché arrivarono in città il 2 maggio, quando i combattimenti non erano ancora conclusi, e ricevettero la resa dei reparti tedeschi. Gli jugoslavi comunque imposero la loro amministrazione e quel che ne seguì fu una sovrapposizione non concordata di zone di occupazione, che generò la prima crisi diplomatica del dopoguerra, cioè la "crisi di Trieste".
Fu la crisi diplomatica apertasi nell’immediato dopoguerra a seguito delle pretese incrociate del governo jugoslavo e di quelli inglesi ed americano di occupare la Venezia Giulia fino alle decisioni della conferenza della pace. Gli jugoslavi sostenevano il loro diritto in quanto primi occupatori nonché alla luce delle loro storiche rivendicazioni sui territori giuliani. Gli anglo-americani ritenevano indispensabili il controllo di Trieste in quanto porto dell’Austria e reclamavano mano libera nella Venezia Giulia, poiché era parte dell’Italia, che rientrava nel teatro di operazioni anglo-americano. Inoltre, inglesi ed americani sospettavano che dietro la mossa jugoslava si celasse il tentativo sovietico di estendere la propria area di controllo nel Mediterraneo, zona d’influenza occidentale, mentre negava uguale facoltà agli alleati nell’Europa orientale.
Per questo, la crisi assunse toni molto aspri, che già prefiguravano gli antagonismi della guerra fredda (gli alleati paragonarono quello che interpretavano come un colpo di mano jugoslavo ai comportamenti della Germania nazista e del Giappone nell’anteguerra) ed assunse anche una dimensione militare con spostamenti cospicui di truppe. La crisi venne però risolta nello spirito della Grande alleanza di guerra, perché Stalin, chiamato direttamente in causa, costrinse il governo jugoslavo a sedersi al tavolo del negoziato. Ne seguì l’accordo di Belgrado del 9 giugno 1945, secondo il quale, in attesa delle decisioni della conferenza della pace, la Venezia Giulia sarebbe stata divisa in due zone di occupazione: la zona A, retta da un Governo militare alleato, e la zona B, affidata ad un'amministrazione militare jugoslava. Le due zone erano separate da una linea di demarcazione, chiamata «linea Morgan».
Il Trattato di pace conclusivo della seconda guerra mondiale, firmato dall’Italia il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 15 settembre 1947, prevedeva il trasferimento alla sovranità jugoslava di quasi tutti i territori annessi all’Italia al confine orientale dopo la Grande guerra, vale a dire Zara, Fiume e la Venezia Giulia (province di Gorizia, Pola e Trieste). All’Italia rimase soltanto la parte meridionale della provincia di Gorizia, a prevalente popolamento italiano, con il capoluogo e la città industriale di Monfalcone. Inoltre, dal momento che nessun accordo era risultato possibile sulla città di Trieste, si decise di internazionalizzarla assieme ad un piccolo lembo di territorio circostante (Territorio Libero di Trieste). Tale soluzione fu accolta con favore sia dai sovietici, perché avevano promesso al governo jugoslavo di impedire che Trieste andasse all’Italia, sia dai governi di Washington, Londra e Parigi, perché le tre potenze ritenevano essenziale che Trieste, porto dell’Austria, non cadesse in mano jugoslava, cioè sovietica. Al riguardo, l’internazionalizzazione con la garanzia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sembrava una soluzione più sicura da eventuali colpi di mano jugoslavi, che non l’affidamento della città ad un’Italia sconfitta, disarmata ed internazionalmente isolata.
L’art. 21 del Trattato di pace entrato in vigore il 15 settembre 1947 prevedeva la costituzione di uno stato cuscinetto fra Italia e Jugoslavia, il Territorio Libero di Trieste (TLT), costituito dalla fascia costiera istriana fra il fiume Timavo a nord ed il Quieto a sud. Il Trattato però non costituiva il TLT, ma si limitava a fissare la procedura per la sua costituzione. La prima tappa, vale a dire l’approvazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di uno Statuto permanente fu compiuta, ma non la seconda, cioè la nomina, sempre da parte del Consiglio di sicurezza, di un Governatore, a causa dei veti incrociati di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia ed Unione Sovietica. Agli inizi del 1948 gli anglo-americani decisero di bloccare di fatto la procedura, perché si convinsero che il TLT non sarebbe stato vitale e quindi vi era il rischio che cadesse in mano comunista, cioè jugoslava, quindi sovietica. Preferirono quindi il mantenimento dello status quo, in base al quale la zona A del territorio continuava a venir amministrata da un Governo militare alleato (GMA) e la zona B da un Governo militare jugoslavo (VUJA). Tale situazione rimase immutata fino all’entrata in vigore del Memorandum di Londra, il 26 ottobre 1954.
Dal punto di vista del diritto internazionale, i giuristi italiani sostenevano che la sovranità italiana non era mai cessata, dal momento che quella del TLT non si era mai instaurata. Viceversa, la giurisprudenza prevalente riteneva che il Trattato di pace avesse posto esplicitamente termine alla sovranità italiana sui territori destinati a dar vita al TLT. Dal momento che la sovranità del TLT non si era mai instaurata, i territori rimanevano res nullius.
Il memorandum di Londra entrato in vigore il 26 ottobre 1954 prevedeva che nella zona A del sempre costituendo Territorio Libero di Trieste l’amministrazione militare anglo-americana venisse sostituita dall’amministrazione italiana e nella zona B l’amministrazione militare jugoslava venisse sostituita dall’amministrazione civile jugoslava. Venne inoltre allegato uno Statuto per la tutela delle minoranze.
Apparentemente, si trattava di una soluzione provvisoria, come richiesto dal governo italiano, che non era in grado di ammettere pubblicamente di aver rinunciato alle sue rivendicazioni sulla zona B per salvare Trieste. Di fatto, si trattava di una spartizione definitiva del mai costituito TLT fra Italia e Jugoslavia, con la garanzia di Stati Uniti e Gran Bretagna.
Negli anni successivi Italia e Jugoslavia procedettero all’ «annessione fredda» delle due zone, esercitandovi tutti gli attributi della sovranità, come la leva militare. Nel 1963 Trieste divenne capoluogo della neocostituita regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, senza alcuna obiezione da parte jugoslava.
La memoria trasforma le percezioni del momento in ricordi di lunga durata. E’ quindi un’attività assolutamente soggettiva. Per chi vuole ricostruire il passato, la memoria – individuale e collettiva – è utilissima per cogliere le sensazioni dei protagonisti (anche nel senso di vittime) e riportare in vita l’atmosfera del tempo. Inoltre, le testimonianze possono rivelarsi indispensabili per colmare i buchi di altre fonti, per reagire al disinteresse degli studi, per rafforzare identità pericolanti. Infine, proprio perché restituiscono la vivezza del vissuto, le testimonianze dirette possiedono in genere un’elevata capacità di coinvolgere gli interlocutori, facendo forza sulla loro emotività.
Contemporaneamente, le memorie sono spesso imprecise nei dettagli, strutturalmente unilaterali, e ripropongono i giudizi sugli eventi formulati a caldo da parte di osservatori privi di visione generale. Se utilizzate quindi in maniera ingenua, possono suscitare diversi problemi. Imprecisioni ed errori fattuali offrono grandi spazi ai negazionisti; spiegazioni storiche complessive fondate unicamente o principalmente sulle memorie si rivelano in genere assai fragili; il materiale della memoria – proprio per la sua unilateralità – costituisce spesso un’ottima base per la creazione di miti politici.
Viceversa, la storia è disciplina critica, fondata sul vaglio ed il confronto tra fonti diverse, comprese quelle della memoria. La storia tende verso l’oggettività e presuppone il distacco dello studioso dalla materia considerata. Se condotte con il necessario rigore metodologico, le analisi storiche risultano molto più precise, sono in grado di superare l’unilateralismo tenendo in considerazione punti di vista diversi, e sono in grado di esprimere giudizi storici complessivi dotati di buona attendibilità. Infine, un aspetto essenziale della pratica storica consiste proprio nella de-mitizzazione del passato.
Una certa tensione fra memoria e storia è quindi piuttosto normale. L’importante è riconoscerne le basi e comprendere quali sono gli specifici apporti che possono venir offerti dai vari modi di accostarsi al passato.
Per gli italiani dell’Istria e di Fiume, la prima fondamentale divisione del lungo dopoguerra avvenne tra chi abbandonò i luoghi d’origine e chi vi rimase; di conseguenza, memorie antagoniste si contesero il primato delle ragioni e del dolore: violenze, sofferenze, tradimenti e lacerazioni familiari costituirono un lutto complicato da elaborare, capace di coinvolgere più generazioni. Una civiltà da secoli radicata in Istria, era stata caratterizzata da profondi fenomeni di ibridismo e al tempo stesso da battaglie identitarie e nazionali, ma di fatto aveva rappresentato un anello forte di congiunzione tra mondo latino e slavo, che aveva abbinato le culture contadine con le identità cittadine, con le lingue dell’industria, della marineria e del commercio. Rispetto a tale koiné, il fascismo, gli eventi bellici, l’insediamento dell’amministrazione jugoslava, frantumarono le esperienze, inasprirono le divisioni su basi nazionali e di micro territorialità, furono capaci di disgregare le comunità e azzerare le identità storiche. Negli anni della guerra fredda fu la politica a riaggregare, a spiegare il passato e a dare un senso alle memorie più sofferte; lo fece ancora una volta all’insegna di una violenta contrapposizione: la colpa era da attribuirsi tutta alla barbarie slavo-comunista, oppure al terrore nazi-fascista che - benché sconfitto - poteva pur sempre sopravvivere in un occidente capitalista e guerrafondaio…. Oggi invece sappiamo che i determinismi e le semplificazioni ideologiche e nazionali sono inefficaci per descrivere società complesse come quelle di frontiera. Inoltre, sia in Italia che in Slovenia e Croazia il ricambio generazionale ha favorito nuove consapevolezze di appartenenza a un territorio comune, dove il tema dell’istrianità ha avviato processi di ricomposizione sociale e politiche culturali inclusive e rispettose delle diversità.
Naturalmente, la divisione delle memorie non ha riguardato soltanto gli italiani dell’Istria e di Fiume, esuli e rimasti. Ancor più profondo è stato il solco fra la memoria degli italiani vittime del regime comunista jugoslavo e quello degli sloveni e croati vittime del regime fascista italiano. A mantenere aperta la frattura ha collaborato poderosamente anche l’uso politico delle memorie offese, vuoi per rafforzare identità, vuoi per costruire consenso.
Dalla sovraesposizione al silenzio
La memoria delle tragedie giuliane e dalmate è stata custodita dalle vittime (esuli) e dai loro familiari (parenti degli infoibati). Fino agli anni ’50 del ‘900 storia e memoria del confine orientale furono assai presenti alla pubblica opinione: la questione di Trieste era aperta o da poco conclusa ed attorno alla sorte del capoluogo giuliano, luogo storico dell’italianità, si era ricostituito il sentimento patriottico dopo la «morte della patria» del settembre 1943. Simbolo del sentire popolare fu la canzone «Vola colomba» che vinse il festival di Sanremo del 1952. La polarizzazione dell’attenzione su Trieste mise però in ombra il destino dell’Istria e quando la città ritornò all’amministrazione italiana, vi fu una caduta generale di interesse.
Nel corso degli anni ’60 cambiò anche il ruolo della Jugoslavia: da nemico alle porte, dopo l’allontanamento dall’Unione Sovietica si trasformò in un prezioso cuscinetto strategico per l’Italia nella logica della guerra fredda. Inoltre, il suo sviluppo economico ne fece un ottimo partner commerciale dell’Italia. Se quindi prima la politica aveva investito nella contrapposizione, poi investì nella distensione, che andava bene alle forze di governo, nella prospettiva dell’interesse nazionale e della Nato, ed andava bene all’opposizione di sinistra, perché la Jugoslavia era pur sempre uno stato comunista. L’opposizione nazionalista era marinale e comunque condizionata dalla fedeltà atlantica.
Naturalmente, l’Italia non era la Jugoslavia, dove parlare di foibe ed esodo era considerata una provocazione. Chi voleva parlare o studiare in Italia, era libero di farlo. Quello che venne meno, fu l’interesse. Se la politica guardava da altre parti, lo facevano di conseguenza anche media ed editori. Le grandi correnti storiografiche (liberale, cattolica, comunista) si occupavano di tutt’altri problemi e quella del confine orientale divenne una storia solo locale. Nella società del miracolo economico, poi, gli italiani non amavano ricordare le storie degli anni bui, della guerra, della sconfitta, della miseria. Gli esuli, per integrarsi, dovettero rinunciare alla dimensione pubblica della loro memoria e spesso si vergognarono di trasmetterla ai figli. La memoria rimase quindi prigioniera degli ambienti della diaspora istriana.
Con la fine della guerra fredda, in Europa molte storie oscurate tornarono alla luce. Lo stesso accadde in Italia. In una prima fase, il governo italiano si preoccupò che la riscoperta della tragedia degli italiani al confine orientale non divenisse oggetto di strumentalizzazione politica in chiave nazionalista, rovinando i rapporti con le neocostituite repubbliche di Slovenia e Croazia. La questione fu perciò delegata agli esperti, cioè a due commissioni storico-culturali, rispettivamente italo-slovena ed italo-croata. La prima concluse i suoi lavori nel 2000 con un rapporto finale. La seconda invece si arenò. Ne uscì comunque una lettura comune, scientificamente fondata, del fenomeno delle foibe, che costituisce tuttora il punto di riferimento degli studi.
In una seconda fase invece, agli inizi del nuovo secolo, prevalse l’esigenza di lenire la ferita della memoria, con l’istituzione nel 2004 di un Giorno del ricordo «della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra (1943-1945), e della più complessa vicenda del confine orientale». L’istituzione di tale solennità, oltre a testimoniare la vicinanza delle istituzioni e della comunità nazionale alle vittime di quelle vicende, ha favorito la moltiplicazione degli studi e la divulgazione delle conoscenze della storia della frontiera adriatica.
Contemporaneamente, la valorizzazione di una delle memorie divise delle regioni adriatiche, quella degli italiani per molti versi confliggente con quelle degli sloveni e dei croati, suscitò reazioni vivaci nelle due repubbliche ex jugoslave. Si tratta di una dinamica comune anche ad altri contesti europei, dove peraltro le massime istituzioni degli stati contermini avviarono tempestivamente iniziative di pubblica riconciliazione. Tali iniziative tardarono invece fra Italia, Slovenia e Croazia e di conseguenza ne nacque una crisi diplomatica. In Slovenia venne istituita la Festa del ritorno del Litorale sloveno alla Jugoslavia. In Croazia si accese una polemica assai aspra fra il presidente della repubblica ed i vertici dello stato italiano. La crisi venne superata nel 2010 con un incontro a Trieste fra i tre presidenti della repubblica, un pellegrinaggio congiunto ad alcuni luoghi della memoria ed un concerto finale di pace nella piazza principale della città. L’anno successivo un incontro di riconciliazione fra i presidenti italiano e croato venne tenuto a Pola.
Come furono accolti i tedeschi in Istria nell’autunno del 1943?
Da parte di alcune comunità italiane come liberatori, perché il loro arrivo faceva cessare l’ondata di arresti da parte dei partigiani croati. Inoltre, alcuni reparti tedeschi avevano come guide gerarchi fascisti che erano riusciti a fuggire in tempo dall’Istria dopo l’armistizio ed ora vi facevano ritorno per liberare o vendicare i loro conoscenti.
In realtà, l’offensiva germanica fece molte più vittime (circa 2.000) delle foibe ed a cadere non furono solo partigiani, ma anche civili slavi ed italiani. Tuttavia, nelle comunità italiane la memoria delle stragi tedesche rimase debole, assimilata alle “nomali” violenze di guerra, mentre le foibe costituirono un vero e proprio trauma. E ciò perché gli atti di violenza compiuti dai partigiani erano espressione di un ribaltamento totale degli equilibri nazionali e sociali nella regione. Ancor di più, le foibe sembravano dare conferma sanguinosa al pregiudizio, risalente già all’800, della “minaccia slava”, lanciando il messaggio che quando gli slavi ottenevano il potere, lo usavano per eliminare gli italiani.
E’ vero che gli infoibati vennero gettati negli abissi ancora vivi?
L’infoibamento in linea di massima fu un metodo di eliminazione dei cadaveri, non di uccisione delle vittime. Di solito, i condannati venivano allineati sull’orlo della foiba (o altra cavità) legati con il filo di ferro e sottoposti a fucilazione collettiva. Poteva quindi succedere che qualcuno non venisse ucciso dalle pallottole ma dalla caduta. La mancanza del colpo di grazie spiega come mai, in singoli casi, alcuni condannati riuscirono per salvarsi, perché sopravvissero fortunosamente sia alla scarica di fucileria che al salto.
L’infoibamento in linea di massima fu un metodo di eliminazione dei cadaveri, non di uccisione delle vittime. Di solito, i condannati venivano allineati sull’orlo della foiba (o altra cavità) legati con il filo di ferro e sottoposti a fucilazione collettiva. Poteva quindi succedere che qualcuno non venisse ucciso dalle pallottole ma dalla caduta. La mancanza del colpo di grazie spiega come mai, in singoli casi, alcuni condannati riuscirono per salvarsi, perché sopravvissero fortunosamente sia alla scarica di fucileria che al salto.
È vero che nelle foibe vennero gettati anche donne e bambini?
Dalla foiba di Lindaro, in Istria, vennero recuperate nell’autunno del 1943 le salme di una donna con due figli, moglie di una camicia nera. Secondo fonti della RSI, un’altra donna, moglie di un milite confinario, sarebbe stata uccisa assieme alla figlia di 11 anni e gettata con lei nella foiba di Jurani. In entrambi i casi le vittime furono prelevate al posto dei parenti, ricercati in quanto fascisti. Lo stesso avvenne per la giovane Norma Cossetto, arrestata nell’autunno del 1943 in luogo del padre a Santa Domenica di Visinada e poi seviziata e uccisa.
Le foibe avevano lo scopo di far fuggire gli italiani dalla Venezia Giulia?
No, nella primavera del 1945 l’obiettivo del governo jugoslavo non era quello di cacciare in massa gli italiani, bensì di mobilitarli, anche a forza, per sostenere l’annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia. Questo perché Stalin aveva informato i dirigenti jugoslavi che le loro rivendicazioni dovevano essere sostenute dal consenso della popolazione, comunque ottenuto. Quindi, fino alla stipula del Trattato di pace un esodo di massa sarebbe stato controproducente per il governo di Belgrado.
Le foibe furono una “resa dei conti”?
In parte sì, ma non principalmente. Naturalmente, la semina di violenza compiuta dal fascismo ebbe il suo peso, così come l’equivalenza fra Italia e fascismo che il regime aveva cercato in ogni modo di accreditare. I conti si fecero anche sul piano sociale, com’è evidente nel caso delle stragi istriane dell’autunno 1943, con il diffuso ribellismo dei contadini croati nei confronti dei possidenti italiani considerati oppressori, dei rappresentanti di uno stato che per i contadini aveva significato tasse e vendita all’incanto delle piccole proprietà, nonché dei ceti urbani italiani, accusati di sfruttare quelli rurali. Tutti questi elementi ed altri ancora, come l’antagonismo nazionale diffuso da decenni, contribuirono a creare un clima da resa dei conti in senso rivoluzionario.
Tuttavia, l’organizzazione e la gestione della violenza vennero dall’alto, per opera dei quadri del movimento di liberazione croato (jugoslavo) nel 1943 e degli organi dello stato jugoslavo, a cominciare dalla polizia politica (OZNA) nel 1945. Si trattò quindi di un tipico caso di violenza di stato, voluta dal nuovo potere per distruggere quello precedente mediante l’azione di sangue e gettare così le basi del nuovo ordine.
La differenza principale fra le stragi giuliane del 1945 e quelle avvenute ovunque nell’Europa occidentale, Italia compresa, alla fine della guerra sta proprio in questo: le violenze di massa non erano solo resa dei conti con il passato, ma strumento strategico per l’edificazione del futuro, così come nel resto della Jugoslavia.
Le foibe furono un atto di genocidio?
No, nel corso del ‘900 la lotta nazionale e politica lungo la frontiera adriatica generò gravissimi scoppi di violenza, ma i diversi attori non ebbero mai progetti vicendevolmente genocidari. L’unica comparsa di logiche genocidarie è costituita dagli aspetti locali della Shoah.
Le foibe, intese come uccisioni di massa, furono un atto di violenza politica estrema, nell’ambito dei comportamenti stragisti adottati dal movimento di liberazione jugoslavo in tutto il Paese al momento della liberazione dai tedeschi e della presa del potere. In quelle settimane del 1945 la Venezia Giulia era integralmente occupata dalle truppe jugoslave, che la consideravano non terra di conquista, ma proprio territorio nazionale liberato.
Le foibe giuliane furono un atto di “pulizia etnica”?
No, nella primavera del 1945 l’obiettivo del governo jugoslavo non era quello di cacciare gli italiani dalla Venezia Giulia, ma di mobilitarli a forza nella lotta per l’annessione della regione alla Jugoslavia. Questo perché Stalin aveva esplicitamente chiesto ai rappresentati jugoslavi di corroborare le loro rivendicazioni territoriali con il consenso della popolazione, anche italiana. Naturalmente, non occorreva che tale consenso fosse spontaneo. Le stragi quindi, oltre all’intento punitivo, ne avevano altri due: decapitare la società della sua classe dirigente, fedele all’Italia, ed intimidire la popolazione italiana, affinché non si opponesse all’annessione.
In termini generali, l’espressione “pulizia etnica” non può mai venir riferita al gruppo nazionale italiano storicamente insediato nella Venezia Giulia, Fiume e Dalmazia, perché la sua identità italiana aveva solo in parte caratteri etnici (continuità degli insediamenti dall’epoca della romanizzazione), risultando in misura cospicua frutto di processi di integrazione secolari degli apporti provenienti dall’entroterra sloveno e croato, dalla penisola italiana, dal Mediterraneo orientale (soprattutto ebrei e greci dall’Impero ottomano) dall’Ungheria e dai paesi tedeschi. Non a caso quindi, un buon numero di irredentisti italiani e martiri della patria portava nomi tedeschi, slavi e greci: Oberdank, Brunner, Slataper, Stuparich, Giglianovich, Krekich, Xydias.
Le foibe furono una repressione per categorie?
In qualche misura sì, perché il loro obiettivo principale era quello di eliminare intere categorie di persone particolarmente odiate (ad esempio, i membri degli apparati di sicurezza) o gruppi ritenuti pericolosi (ad esempio, i membri dei CLN e gli autonomisti fiumani). Lo scrupolo per l’accertamento delle responsabilità individuali fu variabile. In alcuni casi gli arresti e le liquidazioni vennero condotti nei confronti di persone specifiche, in altri casi dopo l’arresto furono istruiti processi sommari, in altri ancora, all’arresto sulla base di generici sospetti non seguì alcun procedimento, ma – talvolta in modo casuale – l’uccisione o la detenzione anche per lunghi periodi.
Le foibe furono una repressione per quote?
No, nonostante i metodi repressivi utilizzati da parte jugoslava – ed in particolare dalla polizia politica, l’OZNA – fossero ispirati al modello staliniano, non risulta che venissero fissate a priori delle quote di arresti o liquidazioni da rispettare.
A proposito delle foibe, è giusto dire che gli italiani vennero perseguitati solo in quanto italiani?
Sì e no al tempo stesso. No, se per italiani intendiamo le persone di nazionalità italiana, perché gli ordini impartiti dalle autorità in merito erano chiarissimi: “epurare non sulla base della nazionalità, ma del fascismo”. Dunque, una persecuzione politica (il concetto di fascismo era molto ampio) e non nazionale. Sì, se per italiani intendiamo le persone che volevano l’Italia, cioè il mantenimento della sovranità italiana sulla Venezia Giulia. Questo era considerato un reato gravissimo, a prescindere dalla nazionalità di chi lo commettesse.
Fecero più vittime i fascisti italiani dopo la prima guerra mondiale o i comunisti jugoslavi dopo la seconda?
Nel primo dopoguerra e fra le due guerre le vittime del fascismo italiano, comprendendo sia gli atti squadristi che la repressione di stato, furono nell’ordine delle centinaia. Nel secondo dopoguerra le vittime delle azioni non militari del movimento di liberazione e della repressione da parte degli organi dello stato comunista jugoslavo furono nell’ordine delle migliaia. È legittimo quindi parlare di un salto di qualità nella scala della violenza politica, dalla dimensione squadrista alla dimensione stragista.
Tuttavia, nell’instaurare la comparazione va tenuto conto della svolta nell’uso della violenza impressa dalla seconda guerra mondiale. Ovunque essa fece saltare la tradizionale distinzione fra obiettivi militari e civili (si pensi ai bombardamenti, convenzionali e nucleari, sulle città). In particolare, sul fronte orientale il conflitto fu sin dall’inizio guerra di sterminio. In Jugoslavia il conflitto tra occupatori tedeschi ed italiani e movimento di liberazione, mescolato alla guerra civile fra croati e serbi ed alla lotta rivoluzionaria dei partigiani comunisti, sviluppò livelli elevatissimi di violenza, di cui furono partecipi tutte la parti in causa. Lo stragismo si affermò così come pratica di lotta abitudinaria. Dopo l’8 settembre 1943 le dinamiche della guerra in Jugoslavia investirono in pieno la Venezia Giulia e proseguirono nel dopoguerra.
Le foibe furono la causa dell’esodo?
No, le stragi delle foibe non generarono fughe immediate. L’esodo fu un fenomeno lungo, che si protrasse a varie ondate fino alla seconda metà degli anni ’50. Certamente il terrore seminato dalle stragi contribuì ad indebolire la resistenza della popolazione italiana sul suo territorio, anche perché rafforzato da un clima di insicurezza generale e di violenza diffusa da parte della autorità jugoslave, che ricorrevano frequentemente ad intimidazioni, bastonature, arresti e sparizioni. Però l’esodo non fu frutto solo della paura, ma di motivazioni più complesse.
L’esodo fu indotto dalla propaganda del governo italiano?
No, il governo italiano era inizialmente contrario all’esodo. L’Italia aveva dovuto accettare il Trattato di pace, ma ne aveva chiesto immediatamente la revisione, nella speranza di poter recuperare parte almeno dell’Istria. Ovviamente, tale rivendicazione si sarebbe fortemente l’indebolita se la popolazione italiana avesse abbandonato la regione. Di fronte poi alla determinazione degli italiani ad esodare, il governo organizzò il meccanismo dell’accoglienza e dell’assistenza.
Nella zona B del mai costituito Territorio libero di Trieste, sotto controllo jugoslavo ma la cui sorte rimase impregiudicata fino al 1954, il governo italiano fece ogni sforzo, tramite il CLN dell’Istria, per incoraggiare la popolazione italiana a rimanere sul posto.
L’esodo fu un atto di “pulizia etnica”?
Paradossalmente, si potrebbe dire che se l’esodo fosse stato “soltanto” un atto di “pulizia etnica”, oggi in Istria ci sarebbero forse 100.000 italiani. Il punto è, che il gruppo nazionale italiano non aveva un profilo solo etnico, perché l’italianità adriatica è composita, frutto in parte di continuità etnica ed in parte di processi di integrazione secolare. Da parte jugoslava gli italiani di origine non etnica erano considerati slavi italianizzati, non da espellere, ma da ricondurre – ovviamente, anche senza il loro consenso – alla nazionalità “originaria”.
L’esodo invece interessò tutti gli italiani che si consideravano tali, a prescindere dalle loro origini, e che volevano difendere la loro identità nazionale, il che si rivelò impossibile nella Jugoslavia comunista. L’esodo fu quindi l’abbandono forzato della propria terra di insediamento storico, da parte di una componente nazionale autoctona, di origine plurale ma unificata dalla lingua, dalla cultura e dal comune sentire italiano. Parlare di “pulizia etnica” è quindi un errore ed una formula riduzionista. Più corretto è parlare di una combinazione fra sostituzione nazionale e pulizia di regime.
Il regime comunista jugoslavo desiderava distruggere ogni forma di presenza italiana in Dalmazia, Fiume ed Istria?
No, il regime poteva tollerare alcune forme di presenza italiana, previste dalla politica della “fratellanza”. Quello che il regime intendeva assolutamente distruggere era l’italianità adriatica, cioè la forma storica assunta nel XIX e XX secolo da tale presenza. A ciò veniva contrapposta una nuova forma di identità italiana minoritaria, privata di ogni forma di potere ed influenza, subordinata ai gruppi nazionali slavi fondatori della Federazione jugoslava, fondata sul rifiuto della storia italiana – che il regime considerava inquinata dall’imperialismo, dall’epoca della repubblica di Venezia a Mussolini – e sull’antagonismo nei confronti dello stato italiano. In tale nuova forma di identità si riconobbe inizialmente buona parte della classe operaia, salvo poi ricredersi alla prova dei fatti e soprattutto dopo la crisi del Cominform. La maggior parte della popolazione italiana invece la rifiutò fin dall’inizio e fu rafforzata nella sua determinazione dall’esperienza delle politiche del regime.
Si possono paragonare le foibe alla Shoah?
La storia comparata è assai utile, ma per trarne vantaggio conviene confrontare fenomeni legati da parentele significative. Ad esempio, ha senso paragonare le foibe ad altre stragi avvenute durante la seconda guerra mondiale, in particolare sul fronte orientale ed in Jugoslavia.
In tale modo, ci può render conto di come le medesime pratiche di occultamento dei cadaveri in cavità naturali o artificiali siano state utilizzate da soggetti diversi in tutti i territori rocciosi che rendono difficile lo scavo. Viceversa, il sistema delle fosse comuni venne adottato dove la natura del suolo rendeva facile l’operazione, magari costringendo le vittime a scavare le fosse prima di venir uccise. Si possono citare al riguardo i casi delle fosse di Katyn per mano sovietica, ovvero di molte stragi naziste nei Paesi Baltici (Liepāja, Ponary), in Bielorussia (Bronna Góra), in Ucraina (Gurka Polonka). A Babij Jar (Ucraina) venne usato un fossato già esistente. Come già accennato, largamente diffusa anche in contesti diversi fu la pratica di condurre i condannati legati fra di loro con il filo di ferro sino all’orlo della cavità, per poi fucilarli sommariamente sul posto. La caduta rendeva inutile il colpo di grazia.
Invece, privo di significato – se non sul piano della pietà – è il confronto con la Shoah, fenomeno radicalmente diverso. Non è paragonabile la scala delle vittime: nell’ordine di grandezza dei milioni nel caso della Shoah, delle migliaia in quello delle foibe. Soprattutto, la Shoah appartiene ad una categoria completamente diversa, che è quella dei genocidi; per portare a compimento lo sterminio vennero adottate diverse tecniche, fra cui anche quella delle stragi, come nei casi citati più sopra.
Si può paragonare l’esodo alla Shoah?
Vale il discorso già fatto per le foibe. Mentre la Shoah fu un genocidio, che quindi può venir paragonato, ad esempio, a quello degli armeni, l’esodo dei giuliano-dalmati rientra fra gli spostamenti forzati di popolazioni, che possono avvenire secondo tre modelli diversi: le deportazioni, (il potere individua un gruppo bersaglio e provvede al trasferimento altrove dei suoi membri); le espulsioni (il potere individua un gruppo bersaglio ed emana delle norme che costringono i suoi membri ad abbandonare il territorio, pena sanzioni gravissime) e gli esodi (il potere individua un gruppo bersaglio e crea le condizioni ambientali che, pur in assenza di qualsiasi provvedimento formale, spingono i suoi membri ad abbandonare il territorio). La vicenda dei giuliano-dalmati può quindi venir utilmente comparata con le deportazioni naziste e staliniane, con l’espulsione dei tedeschi dall’Europa centrale dopo la seconda guerra mondiale e con l’esodo dei circassi dalla Crimea alla metà dell’800.
Riguardo alle città italiane come Zara, Fiume, Pola e Capodistria si può parlare di urbicidio?
Sicuramente sì. Per “urbicidio”, si intende l’accanimento contro le città che secondo alcuni storici avrebbe caratterizzato il ‘900, così come i genocidi ed i campi di concentramento. Le motivazioni non riguardano solo l’importanza economica e strategica dei centri urbani, ma il loro valore simbolico per l’identità dei popoli che si volevano colpire. La distruzione può essere materiale, ad esempio attraverso i bombardamenti, e nell’area adriatica è questo il caso di Zara. La distruzione però può riguardare la cittadinanza, attraverso un ricambio forzato della popolazione. Così è avvenuto per molte città dell’Europa centro-orientale, come Danzica, Könisberg, Leopoli, Wroclaw, Salonicco, Smirne; nell’Adriatico orientale è il caso di Fiume, Pola e Capodistria. In tali circostanze, il concetto di “urbicidio” può venir meglio precisato, integrandolo con la nota distinzione presente nella lingua latina fra urbs, in quanto complesso urbano, e civitas (che equivale al greco polis), in quanto comunità di cittadini portatori di una specifica fisionomia culturale. Nell’area adriatica ad andare in crisi fu soprattutto la seconda, prevalentemente identificantesi con la tradizione romanza. Si potrebbe quindi parlare di “policlastia”.
A chi è corretto attribuire la colpa della perdita dell’Istria e dell’esodo dei giuliani dalmati?
Zara, Fiume l’Istria erano state annesse all’Italia a seguito della vittoria nella prima guerra mondiale. Le sono state tolte a seguito dell’esito della seconda guerra mondiale, voluta e perduta dal regime fascista. È al fascismo pertanto che va imputata la responsabilità prima degli eventi scatenanti la crisi dell’italianità adriatica. Quanto all’esodo, la spinta determinante venne impressa dalle politiche attuate sul territorio dal regime comunista jugoslavo, che costrinsero le comunità italiane all’esilio per evitare il collasso identitario.
Nella storia delle terre adriatiche è possibile distinguere un nazionalismo buono, legato ad istanze di liberazione dei popoli, da un nazionalismo cattivo, di tipo sopraffattorio?
Magari! Purtroppo i movimenti nazionali nacquero, in pieno Romanticismo, quali espressioni della volontà di liberazione di popoli – o meglio, di parte delle loro élites – che si sentivano oppresse o comunque limitate nella loro possibilità di realizzazione nazionale nell’ambito dell’Impero asburgico. Crebbero però rapidamente in antagonismo l’uno contro l’altro, sviluppando una formidabile serie di pregiudizi incrociati e contendendosi duramente il potere locale. Tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 furono pesantemente influenzati dal clima di acceso nazionalismo imperialista diffuso in tutta Europa. Dopo il collasso dell’Impero asburgico, le rivendicazioni nazionali sui medesimi territori mistilingui e multiculturali dell’Adriatico orientale si sommarono agli obiettivi di potenza degli stati successori dell’Austria, cioè l’Italia e la Jugoslavia. Inoltre, i movimenti nazionali utilizzarono senza freni la forza dei rispettivi stati di riferimento per schiacciare i loro avversari, cioè le minoranze rimaste dalla “parte sbagliata” del confine. Ciò accadde nel primo dopoguerra a vantaggio degli italiani e nel secondo a vantaggio degli sloveni e croati. È evidente che chi prima era stato oppresso lottò per la propria liberazione, trasformandosi però a sua volta in oppressore. Il risultato cumulativo è stata la riduzione ai minimi termini delle minoranze all’interno degli “stati per la nazione”.
È possibile puntare ad una memoria condivisa delle genti di frontiera (italiani, sloveni e croati)?
Certamente no. Quello della “memoria condivisa” è un mito privo di fondamento. La memoria infatti rappresenta il momento della soggettività, che cristallizza nel ricordo la percezione dei fatti. Di conseguenza, le uniche forme di condivisione, nell’analisi del passato, possono viceversa venire dalla pratica del comune metodo storico, che presuppone il distacco critico dalle vicende e dalle percezioni che esse hanno generato.
È possibile riconciliare le memorie delle genti di frontiera (italiani, sloveni e croati)?
È difficile, ma alcune esperienze mostrano che è possibile. Il primo passo sta nel riconoscimento dell’esistenza di memorie diverse ed antagoniste, dotate tutte di una loro legittimità, molto spesso basata sul dolore. Questa è la premessa per uscire dalla dimensione micidiale dell’unilateralismo. Il secondo passo consiste nel rispetto delle memorie altrui, anche di coloro che la propria memoria ha presentato come nemici, caricandoli quindi di tutti i possibili attributi negativi e denunciandoli come responsabili delle proprie disgrazie. L’ultimo passo, certamente il più arduo, è quello della “purificazione della memoria”, con ciò intendendo il riconoscimento che anche nella propria memoria ci sono delle zone oscure, che possono mettere in discussione l’autorappresentazione in chiave esclusivamente vittimista.
È questo il passaggio essenziale per potersi aprire alle ragioni degli altri. E’ più facile compierlo, se oltre che sul piano intellettuale, ci muove anche su quello affettivo: se infatti il ricordo non si può condividere, il dolore invece sì e questo tipo di condivisione di un’esperienza così profondamente ed universalmente umana come la sofferenza, può aprire la strada ai passi successivi. E’ difficilissimo infatti procedere lungo le vie della riconciliazione, se alla dimensione della conoscenza non si accompagna quella della pietà.
Opere di carattere generale
Dall'impero austro-ungarico alle foibe. Conflitti nell'area alto-adriatica, contributi di Alessandra Algostino [et al.], Bollati Boringhieri, 2009.
Marina Cattaruzza, L'Italia e il confine orientale, 1866-2006, Il Mulino, 2006.
Istria, Quarnero, Dalmazia. Storia di una regione contesa dal 1796 alla fine del 20. Secolo, a c. di Marco Cuzzi, IRCI 2009.
Istria nel tempo, a c. di Egidio Ivetic, CRS 2006.
Egidio Ivetic, Un confine nel Mediterraneo. L'Adriatico orientale tra Italia e Slavia (1300-1900), Viella, 2014.
Piero Purini, Metamorfosi etniche. I cambiamenti di popolazione a Trieste, Gorizia, Fiume e in Istria 1914-1975, Kappa Vu, 2010.
Raoul Pupo, La catastrofe dell’italianità adriatica in «Qualestoria», 2016, n. 2.
Marta Verginella, Il confine degli altri: la questione giuliana e la memoria slovena, Donzelli, 2008.
Rolf Wörsdörfer, Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955, il Mulino, 2009.
Fascismo di confine
Elio Apih, Italia, fascismo e antifascismo nella Venezia Giulia. 1918-1943, Laterza, 1966.
Milica Kacin-Wohinz, Jože Pirjevec, Storia degli sloveni in Italia, Marsilio, 1998.
Anna Vinci, Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale 1918-1941, Laterza, 2011.
Occupazioni italiane in Jugoslavia
L'occupazione italiana della Iugoslavia, 1941-1943, a c. di Francesco Caccamo, Luciano Monzali, Le lettere, 2008.
Eric Gobetti, Alleati del nemico. L'occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943), Laterza, 2013.
Federico Goddi, Fronte Montenegro. Occupazione italiana e giustizia militare (1941-1943), LEG, 2016.
Amedeo Osti Guerrazzi, Esercito italiano in Slovenia, 1941-1943. Strategie di repressione antipartigiana, Viella, 2011.
Foibe
William Klinger, Ozna, il potere del popolo, Luglio, 2015.
Guido Rumici, Infoibati 1943-1945. I nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti, Mursia, 2002.
Raoul Pupo, Roberto Spazzali, Foibe, Bruno Mondadori, 2003.
Jože Pirjevec, Foibe. Una storia d'Italia, Einaudi, 2009
Raoul Pupo, Trieste ’45, Laterza, 2014.
Nevenka Troha, Chi avrà Trieste? Sloveni e italiani tra due stati, Irsml, 2014.
Giampaolo Valdevit, Foibe. Il peso del passato. Venezia Giulia 1943-1945, Marsilio, 1997.
Relazione della Commissione mista storico-culturale italo-slovena, in «Qualestoria», n. 2, 2000.
Esodo
La comunità nazionale italiana nei censimenti jugoslavi 1945-1991, Alessandra A. Argenti Tremul [et al.], Trieste-Rovigno, CRSR, 2011.
Pamela Ballinger, La memoria dell’esilio. Esodo e identità al confine dei Balcani, Roma, Il Veltro, 2010.
Carlo Spartaco Capogreco, I campi del duce : l'internamento civile nell'Italia fascista, 1940-1943, Einaudi 2004.
C. Colummi, L. Ferrari, G. Nassisi, G. Trani, Storia di un esodo. Istria 1945-1956, Irsml, 1980
Guido Crainz, Raoul Pupo, Silvia Salvatici, Naufraghi della pace. Il 1945, i profughi e le memorie divise d'Europa, Donzelli, 2008.
Costantino Di Sante, Nei campi di Tito: soldati, deportati e prigionieri di guerra italiani in Jugoslavia (1941-1952), prefazione di Nevenka Troha, Ombre corte, 2007
Antonio Ferrara, Niccolò Pianciola, L'età delle migrazioni forzate. Esodi e deportazioni in Europa. 1853-1953, Il Mulino, 2012.
Patrick Karlsen, Frontiera rossa, Leg, 2010.
Olinto Mileta Mattiuz, Popolazioni dell'Istria, Fiume, Zara e Dalmazia, 1850-2002. Ipotesi di quantificazione demografica, ADES, 2005.
Enrico Miletto, Istria allo specchio. Storia e voci di una terra di confine, Franco Angeli, 2007
Orietta Moscarda, Il «potere popolare» in Istria 1945-1953, CRS, 2016.
Raoul Pupo, Il lungo esodo, Rizzoli, 2005.
Gloria Nemec, Un paese perfetto. Storia e memoria di una comunità in esilio: Grisignana d'Istria, 1930-1960, LEG, 1998.
Gloria Nemec, Nascita di una minoranza. Istria 1947-1965. Storia e memoria degli italiani rimasti nell’area istro-quarnerina, Rovigno, Unione italiana Fiume, UPT Trieste, Università di Trieste, CRSR, 2012.
Guido Rumici, Fratelli d’Istria: 1945-2000 italiani divisi, Mursia, 2001.
Giacomo Scotti, Il gulag in mezzo al mare, Lint, 2012.
Sandi Volk, Esuli a Trieste. Bonifica nazionale e rafforzamento dell’italianità sul confine orientale, Kappa Vu, 2004.
Questione di Trieste
Massimo De Leonardis, La diplomazia atlantica e la soluzione del problema di Trieste, 1952-1954, Edizioni scientifiche italiane, 1992.
Raoul Pupo, Trieste ’45, Laterza, 2014.
Giampaolo Valdevit, La questione di Trieste 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale, Franco Angeli, 1986.
Giampaolo Valdevit, Il dilemma Trieste. Guerra e dopoguerra in uno scenario europeo, IRSML, 1999.
Giampaolo Valdevit, Trieste 1953-1954. L'ultima crisi, MGS press, 1994.
Amnesie e ricordi
Raoul Pupo, Due vie per riconciliare il passato delle nazioni? Dalle Commissioni storico culturali italo-slovena e italo-croata alle giornate memoriali, in «Italia contemporanea», n. 282, 2016, pp. 233-256.
Guido Crainz, Il dolore e l'esilio: l' Istria e le memorie divise d'Europa, Donzelli, 2005.
Le carte cosiddette “etniche” hanno avuto una gran fortuna tra la fine dell’800 e la metà del ’900. Il loro scopo era quello di illustrare in maniera evidente la distribuzione del popolamento nazionale all’interno di un’area fortemente plurale e contesa, come quella adriatica. Per questo motivo, sono state largamente usate dalle propagande nazionali.
Tuttavia, questo tipo di cartografia tematica – spesso affascinante sia per i colori usati, che per il colpo d’occhio che consente – va utilizzata in maniera critica. In realtà, la base delle mappe è costituita dai censimenti linguistici. Trasformare un’informazione sulle principali lingue parlate in un dato sull’appartenenza nazionale, è un’operazione scorretta, perché la lingua è soltanto uno – anche se certo assai importante – fra i marcatori delle identità nazionali.
Inoltre, anche i censimenti linguistici presentano alcune criticità. I censimenti austriaci e quelli italiani rilevavano la lingua d’uso e non la lingua materna. Nessuna delle due soluzioni può dirsi astrattamente “giusta”, ma ciascuna offre un’immagine della realtà diversa dall’altra. I dati dei censimenti, per giunta, vennero talvolta manipolati dalle autorità del momento, tanto da richiedere poi in sede storica alcuni aggiustamenti. Infine, i censimenti che rilevano la lingua prevalente dei singoli cittadini, cancellano la realtà del bilinguismo, in alcune aree assai diffuso. In questo modo, attraverso una serie di passaggi tutti discutibili, i censimenti linguistici, la loro interpretazione in chiave nazionale e la loro rappresentazione cartografica non offrono informazioni “neutre”, ma sono strumenti efficaci dei processi di nazionalizzazione, che mirano a presentare un’immagine della società di frontiera divisa fra blocchi nazionali omogenei.
A che cosa possono dunque servire oggi le “carte etniche”, specie a livello didattico? In primo luogo, a fornire comunque un’informazione generale, a prima vista, sulla distribuzione sul territorio dei gruppi linguistici soggetti al processo di nazionalizzazione. In secondo luogo – ma è l’aspetto più importante sotto il profilo metodologico – ad illustrare come i movimenti nazionali hanno utilizzato le informazioni dei censimenti per costruire “rappresentazioni” del popolamento nazionale che servissero da supporti alle loro rivendicazioni. Si scopre così che sulla base di dati simili si possono disegnare e proporre immagini opposte. Infine, il confronto tra le mappe costruite in base ai censimenti degli inizi del ‘900 e quella invece realizzata a partire dalle rilevazioni di fine secolo, mostra l’ampiezza dei fenomeni di “semplificazione nazionale” avvenuti nell’area dell’Adriatico orientale nel corso di alcuni decenni.
1. La Marche Julienne, realizzata da Josip Roglić, geografo croato (1906-1987) riporta la ripartizione dei gruppi linguistici presenti nel 1910 e 1911 (escluso il distretto di Veglia).
La mappa è costruita in modo da individuare anche gli insediamenti linguistici di minori dimensioni. Le dimensioni dei cerchietti non sono proporzionali a quelle degli insediamenti medesimi: la dimensione rappresentata dei centri maggiori differisce poco da quella dei centri minori. Di ciò viene dato correttamente conto nella Legenda, ma l’impressione, voluta, è quella che gli insediamenti sloveni e croati siano assai più cospicui di quelli italiani.
Infine, i colori adoperati per individuare rispettivamente sloveni e croati sono fra loro molto simili, al fine di offrire un’immagine di compattezza del popolamento slavofono, mentre vengono usati colori ben diversi per individuare italofoni e friulanofoni, considerati come un’entità a parte. La soluzione grafica prescelta cerca quindi di rappresentare lo slogan tipico del nazionalismo sloveno e croato, secondo il quale gli insediamenti italiani sono “isole in un mare slavo”, oppure “bottoni italiani su di un mantello slavo”.
2. Carlo Schiffrer, Carta dei limiti nazionali italo-jugoslavi
La mappa di Carlo Schiffrer, storico e geografo italiano (1902-1970) si fonda sulle sue elaborazioni del censimento del 1921, i cui dati differiscono, anche se non di molto, da quelli del 1910.
La rappresentazione è speculare a quella di Roglić. In questo caso, la proporzione fra i palloni rappresentanti rispettivamente gli insediamenti maggiori e quelli minori, è tale da sottolineare le grandi dimensioni dei centri abitati italiani di contro agli insediamenti sparsi slavi.
Inoltre, l’intensità del colore segnala la densità della popolazione.
Infine, le strisce trasversali indicano le aree di bilinguismo diffuso. Scopo della mappa è quello di rappresentare lo slogan tipico del nazionalismo italiano, secondo il quale gli insediamenti italiani sono “oasi in un deserto slavo”.
3. Carta etnica della Slovenia occidentale, dell’Istria e del Quarnero, elaborata dal geografo triestino Dragan Umek sulla base dell’ultimo censimento jugoslavo, quello del 1991.
Il sistema di rappresentazione adottato, a cerchietti anche di minime dimensioni, consente di individuare anche le comunità nazionali meno numerose, vale a dire gruppi di 5-25 unità.
È questo il caso delle comunità italiane, talvolta piccolissime, rimaste in Jugoslavia (e successivamente in Slovenia e Croazia) dopo l’esodo.

Cartina con i confini nell'Alto adriatico tra la Repubblica di Venezia e l'Austria nel 1797
Cartina realizzata da Franco Cecotti, Irsrec FVG

Cartina con indicate le foibe giuliane, maggio 1945
Cartina realizzata da Franco Cecotti, Irsrec FVG
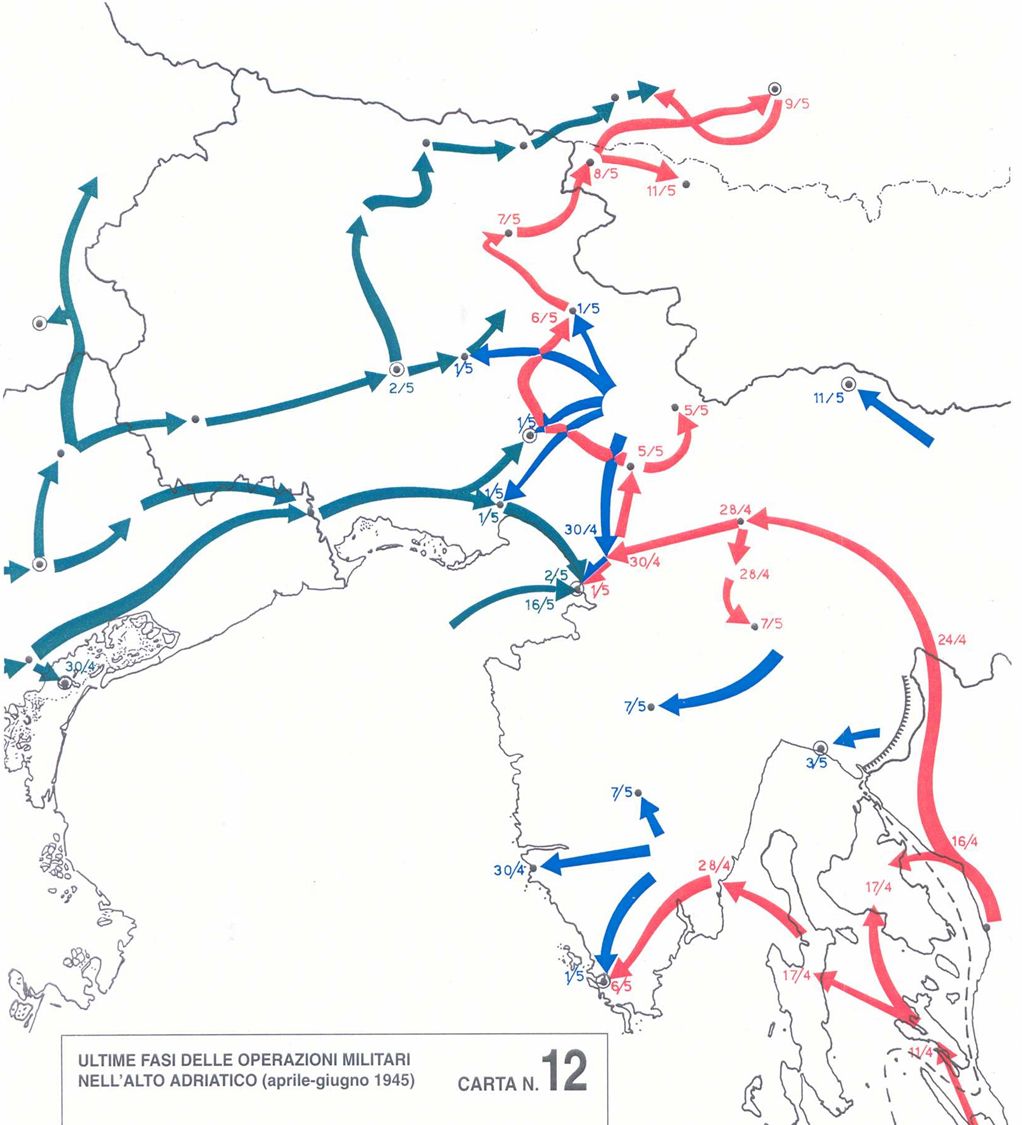
Cartina riportante le ultime fasi delle operazioni militari nell'Alto adriatico, aprile-giugno 1945
Cartina realizzata da Franco Cecotti, Irsrec FVG
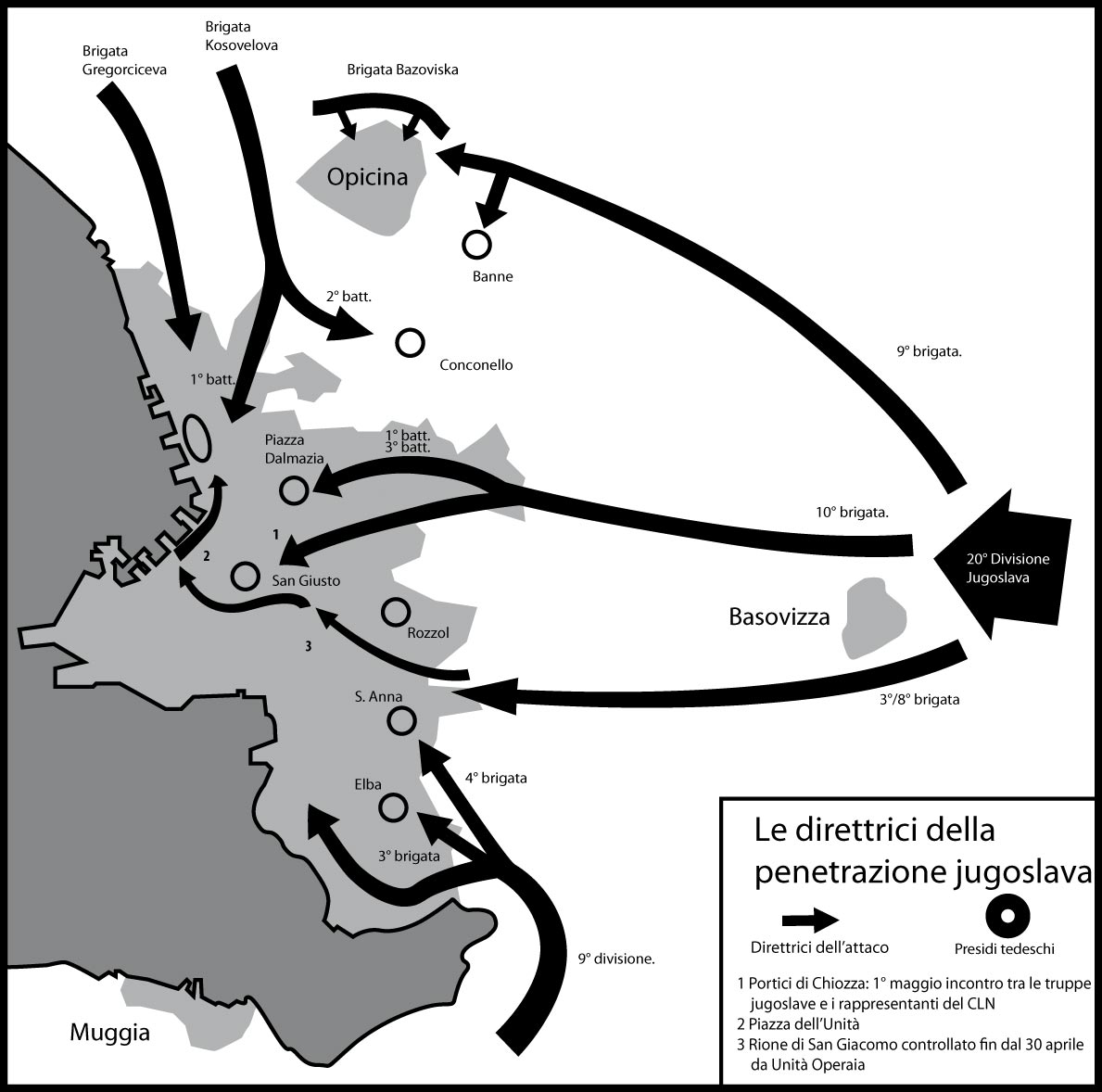
Cartina riportante le direttrici della penetrazione jugoslava a Trieste
Cartina realizzata da Michele Pupo

Cartina del Territorio libero di Trieste dal 1947 al 1954
Cartina realizzata da Franco Cecotti, Irsrec FVG

Cartina del Territorio libero di Trieste, 1947-1954
Cartina realizzata da Franco Cecotti, Irsrec FVG
Testa di partigiano esibito come macabro trofeo da alcuni militi italiani,1942-1943
Archivio fotografico Irsrec FVG

Quisca, 20 dicembre 1946, operazioni di recupero di salme dalla foiba di Figovizza
Archivio fotografico Irsrec FVG

Quisca, 20 dicembre 1946, operazioni di recupero di salme dalla foiba di Figovizza
Archivio fotografico Irsrec FVG

Quisca, 20 dicembre 1946, operazioni di recupero di salme dalla foiba di Figovizza
Archivio fotografico Irsrec FVG
Scritte contro il confine stabilito nel 1954 tra Italia e Jugoslavia
Archivio fotografico Irsrec FVG

Jugoslavi e neozelandesi a colloquio, vicino al Tribunale di Trieste, maggio 1945
Archivio fotografico Irsrec FVG
Trieste, novembre 1953, scontri in piazza Sant'Antonio nuovo tra manifestanti e Polizia Civile
Archivio fotografico Irsrec FVG
Trieste, 26 ottobre 1954, la fine del governo militare alleato. Ritorna l'Italia
Archivio fotografico Irsrec FVG