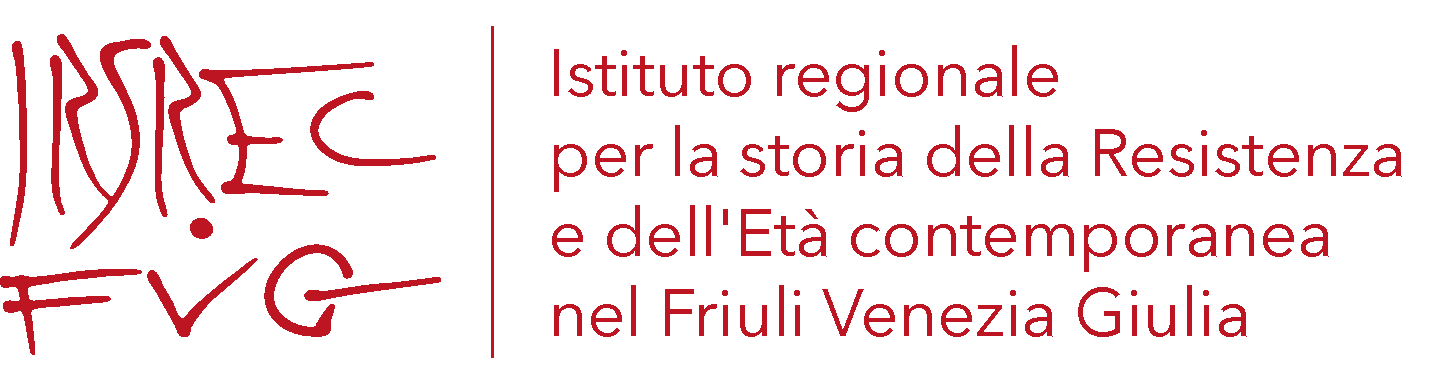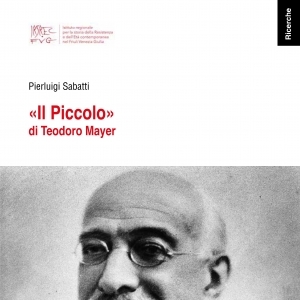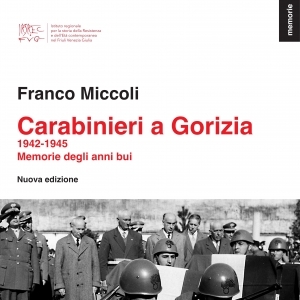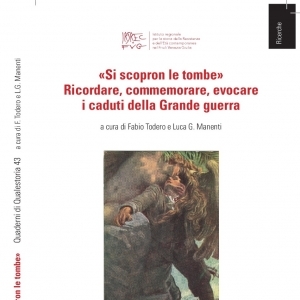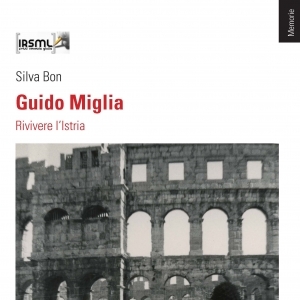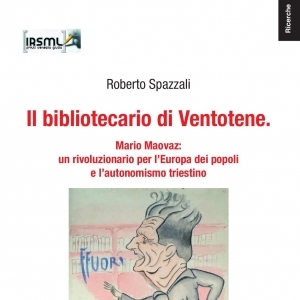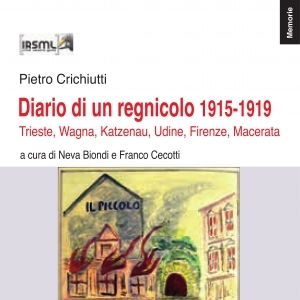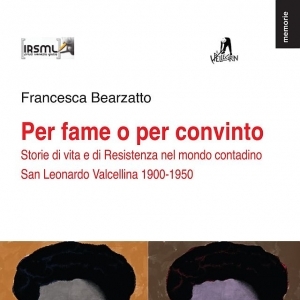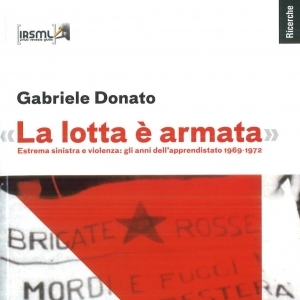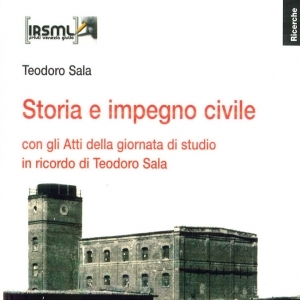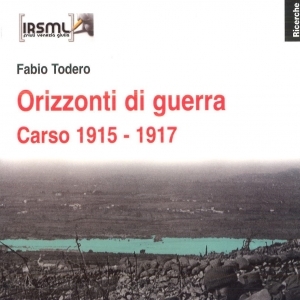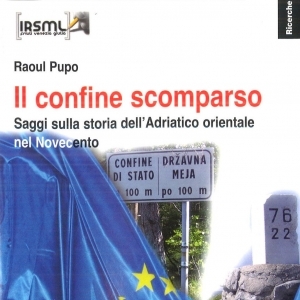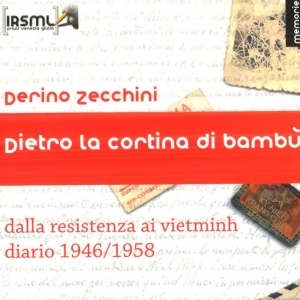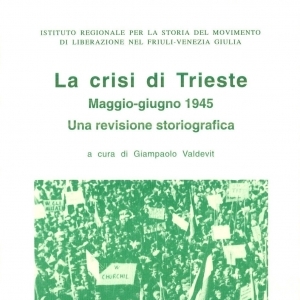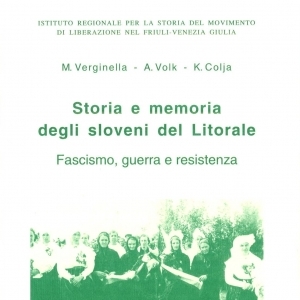Gorizia. Ricostruzione e identità nazionali (1947-1954)
Anna Di Gianantonio, Ennio Francavilla, Tommaso Montanari
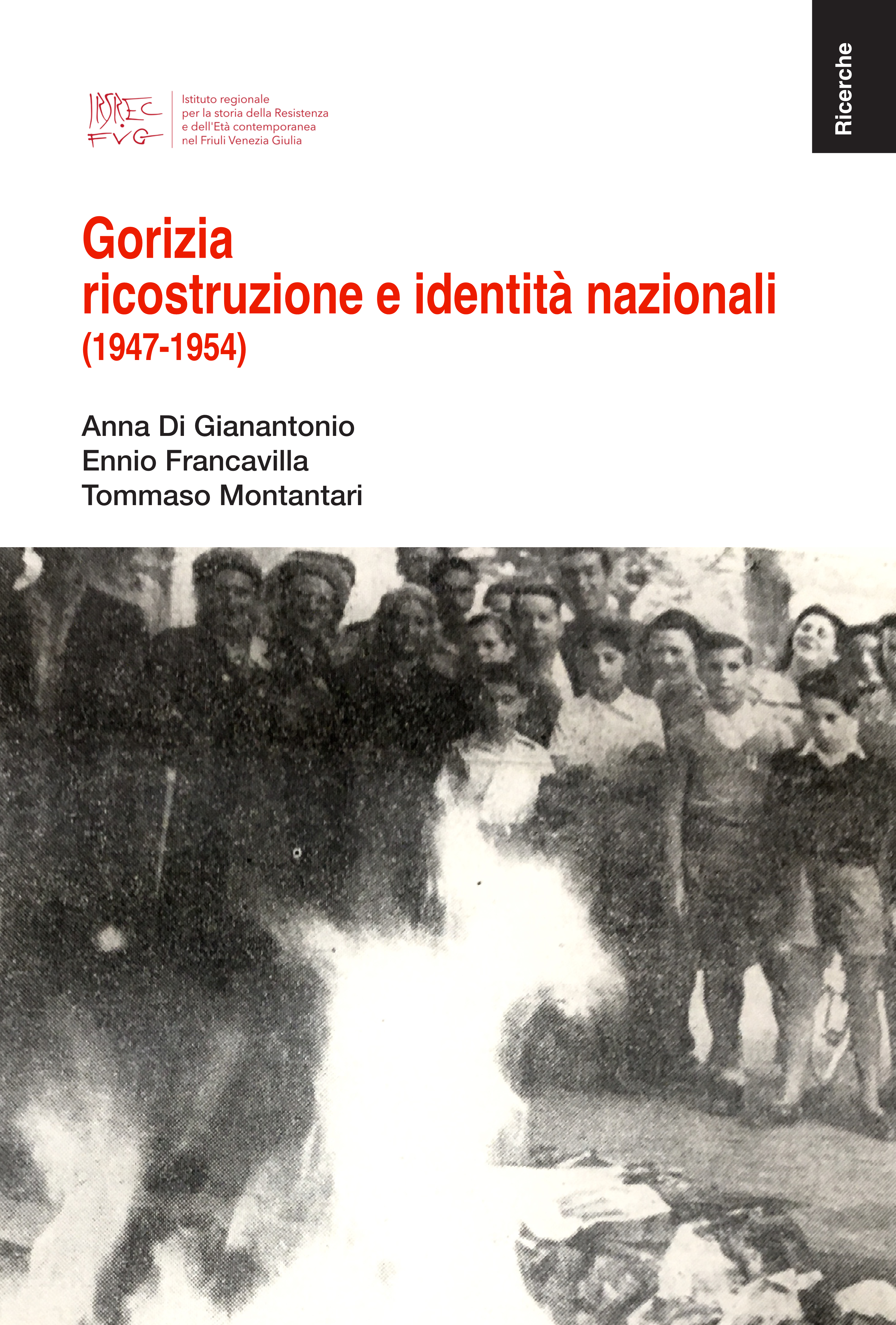
Gorizia
Ricostruzione e identità nazionali (1947-1954)
di Anna Di Gianantonio, Ennio Francavilla, Tommaso Montanari
Il volume è diviso in due parti. La prima analizza le violenze a Gorizia nel 1947 allo stabilirsi del confine con la Jugoslavia. Attori, episodi, forze in campo sono descritte nel dettaglio per mettere in luce il «carattere predatorio» di quegli atti che distinguono ciò che avvenne a Gorizia da quanto accadde nello stesso periodo a Monfalcone e Trieste.
La seconda parte illustra la direzione che prese l’enorme flusso di denaro che giunse a Gorizia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso l’Ufficio zone di confine. La snodo fondamentale per l’erogazione dei fondi fu il prefetto Giovanni Palamara, il quale operò in città nel periodo 1947-1954 e indirizzò i finanziamenti verso le associazioni più attive nella difesa dell’italianità della città. Esse assistettero i bisognosi che davano prova di sentimenti nazionali, ma con i fondi a loro disposizione posero le basi per il futuro politico delle loro classi dirigenti. Il rapporto tra associazioni fu spesso conflittuale, così come quello con il prefetto al momento di presentare i rendiconti delle spese sostenute, incompleti o presentati con gravi ritardi.
Infine compaiono coloro che vennero percepiti come i più pericolosi avversari dell’identità italiana: il clero sloveno, oggetto di minuziosi controlli in ogni loro movimento.
Dalla ricerca emerge così il carattere peculiare della «guerra fredda» in città.
Il volume è frutto della ricerca portata avanti nell'ambito del progetto triennale "Fare e raccontare storia 2021-2023" finanziato dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.
Anna Di Gianantonio è vice presidente dell’Irsrec FVG. Ha utilizzato per i suoi studi le fonti orali e si è occupata prevalentemente di storia delle donne e degli uomini durante il fascismo e la Resistenza e storia degli operai e delle operaie nel territorio isontino.
Ennio Francavilla è insegnante di ruolo all’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «D’Annunzio-Fabiani» di Gorizia e ricercatore presso l’Irsrec FVG. Nel 2022 ha presieduto il convegno organizzato a Trieste dal Centro Studi per la Scuola Pubblica (CESP) dal titolo: «Uso pubblico e politico della Storia».
Tommaso Montanari è insegnante di storia e filosofia presso le scuole secondarie di secondo grado. Si occupa di storia contemporanea della Venezia Giulia, in particolare ha indagato le vicende del secondo dopoguerra e le problematiche dell’identità e della memoria nelle zone di confine; ha collaborato con l’Irsrec FVG e con il Consorzio culturale del monfalconese.
Collana: Quaderni 51
Prima edizione italiana: 2023
Copertina: «Soča», 18/9/1947
267 p.
€ 20,00
ISBN: 9788898796342
INDICE
Ringraziamenti
Archivi consultati
Avvertenza al lettore
Introduzione
Capitolo I
Il ritorno di Gorizia all’Italia: giubilo e violenze 1
Introduzione 1
La lotta per l’appartenenza statale di Gorizia fra propaganda e violenza politica (1945-1947) 2
Il precedente dell’agosto del ’46 12
Il trattato di pace 17
Le peculiarità del caso goriziano 20
Le fonti 21
Cronologia e dinamiche delle violenze 23
Analisi quantitativa e qualitativa delle violenze denunciate 38
Chi erano le persone aggredite? 42
Chi erano gli aggressori? 53
La Divisione Gorizia 62
Il ruolo del GMA e del governo italiano 74
Le reazioni sulla stampa, il dibattito parlamentare, la crisi diplomatica fra Italia e Jugoslavia 83
Epilogo 106
Capitolo II
Il prefetto Palamara: «un uomo veramente abile» 126
L’Ufficio per la Venezia Giulia e i primi conflitti sulle competenze 132
I rapporti tra GMA, Assistenza post-bellica e Ufficio Venezia Giulia 136
I permessi di soggiorno e il pericolo del nemico interno 145
L’emergenza sanitaria e quella degli alloggi a Gorizia e a Monfalcone 150
Lo scandalo sugli appalti e l’assegnazione degli alloggi 153
Il piano prefettizio per la costruzione di nuove case 156
L’assistenza economica e civile dell’UNRRA-Casas 158
La mancanza di alloggi a Monfalcone e lo scontro sulla gestione degli stabili 160
La questione sindacale 163
Le lotte nel secondo dopoguerra 167
Dopo lo sciopero dei dodici giorni 170
Le agitazioni nelle campagne 172
Immigrare o emigrare? Intanto assistere 175
I progetti «nazionali» per la rinascita di Gorizia 179
Quale sviluppo per la nuova provincia di Gorizia? 183
Il dibattito sulla Zona franca 186
L’attuazione della Zona franca 191
Linee ideali e politiche delle associazioni goriziane italiane 193
L’Associazione giovanile italiana 195
La Lega Nazionale e il rapporto con l’AGI 201
L’Associazione partigiani italiani 203
I finanziamenti alle associazioni 207
L’assistenza agli esuli: un’operazione finanziaria vorticosa? 213
1949. Il rapporto centro-periferia e il destino delle associazioni 217
La Divisione Gorizia 229
Il «fronte avverso» 230
La questione dei cognomi 247
Il problema delle scuole slovene 250
Il clero di confine tra paure, conflitti e controlli 254
Indice dei nomi 263
Introduzione
Anna Di Gianantonio, Ennio Francavilla, Tommaso Montanari
Il volume è frutto di una ricerca che intende mettere a fuoco le linee politiche e ideologiche che hanno guidato la ricostruzione di Gorizia nel secondo dopoguerra. Esse furono elaborate principalmente da due soggetti: l’Ufficio Zone di Confine, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto la direzione di Giulio Andreotti, e il suo terminale goriziano, il prefetto Giovanni Palamara. Quest’ultimo non fu un semplice esecutore delle direttive di Roma, ma elaborò progetti, proposte e interventi che partivano dalla sua analisi della realtà locale.
L’arco cronologico va dal 1947, anno del trattato di pace, al 1954, anno in cui l’Ufficio venne chiuso e le sue competenze passarono direttamente alla Presidenza del Consiglio. Nel 1954 inoltre Palamara, apprezzato per il ruolo svolto a Gorizia, venne inviato come Commissario prefettizio a Trieste.
La ricerca ricostruisce il contesto in cui si svolse l’azione del prefetto, il quale dovette affrontare innanzitutto i problemi di una città che dal trattato di pace era stata privata di più di due terzi del suo retroterra economico. A Gorizia e nella sua ridotta provincia mancavano le case e le infrastrutture civili, le industrie erano in crisi e pronte a licenziare, nelle campagne i contadini erano in rivolta per ottenere patti agrari più favorevoli, grave era la diffusione di malattie come la tubercolosi, dovute alla miseria e alle precarie condizioni di vita. Continuava inoltre l’afflusso degli esuli dall’Istria e da Pola, mentre tanti lasciavano la zona B, dal 1947 assegnata alla Jugoslavia, in cerca di casa e lavoro in città, mentre funzionari civili e militari raggiungevano Gorizia dopo l’insediarsi delle autorità italiane e non trovavano adeguati alloggi per le loro famiglie.
La lotta per l’appartenenza statale di Gorizia, contesa fra Italia e Jugoslavia, aveva dato luogo a uno scontro nazionale e ideologico che aveva visto una straordinaria partecipazione di massa, ma che aveva anche lasciato enormi tensioni per un trattato di pace che scontentava ambo le parti. Ciò fu evidente proprio durante il passaggio dei poteri dal Governo militare alleato alle autorità italiane, quando la comunità slovena fu colpita da un’ondata di violenze tanto intensa e distruttiva da essere definita dalla stampa un «pogrom». Decine di sloveni, ma anche alcuni italiani, accusati a vario titolo di aver parteggiato per la Jugoslavia, furono aggrediti e messi alla gogna; furono colpiti i centri della vita politica, economica e culturale dei cosiddetti «slavo-comunisti»; assaltati e devastati case, negozi, locali pubblici. Nonostante le denunce raccolte, i memoriali prodotti dalle organizzazioni slovene e le interpellanze parlamentari, nessun colpevole fu condannato e nessun risarcimento venne offerto alla comunità slovena.
La portata e il significato delle violenze del settembre 1947 trovano ampio spazio nella prima parte del volume, in cui si ricostruiscono brevemente anche gli anni fra la fine della guerra e il ritorno di Gorizia all’Italia. Intanto qui possiamo anticipare che tali violenze si devono interpretare su più livelli: in parte, in relazione ai recenti trascorsi, esse furono la risposta rabbiosa ad un trattato di pace ritenuto «iniquo» e umiliante per gli italiani e una sorta di rappresaglia per le deportazioni subite nel maggio 1945 da quei goriziani che erano stati accusati di fascismo e collaborazionismo; d’altra parte le violenze agli sloveni funsero da monito per il futuro, affinché essi non osassero più mettere in discussione l’italianità di Gorizia. Né, fino ad oggi, i filo-jugoslavi avrebbero ottenuto il riconoscimento della legittimità della loro causa in quanto controparte di quel travagliato periodo storico.
Seppur non nel modo sperato, lo schieramento italiano aveva vinto. Gli sloveni avrebbero dovuto ritirarsi dal centro della città e accettare di farsi assimilare. Fino ad allora uno sloveno non sarebbe stato ritenuto «goriziano», bensì un elemento estraneo ed ostile.
La lotta per l’uso della lingua slovena nei luoghi pubblici, per la restituzione degli edifici sottratti durante il fascismo, per il riconoscimento delle scuole e per la stessa agibilità nel centro città si protrasse per anni, poiché le istanze degli sloveni non vennero prese in considerazione.
Dagli archivi consultati non emerge esclusivamente la conflittualità tra italiani e sloveni, ma anche una interna al fronte patriottico italiano. A Gorizia l’Ufficio Zone di Confine elargì consistenti somme di denaro per associazioni, circoli culturali, giornali, parrocchie, gruppi sportivi, che si ponessero come obiettivo la propaganda dell’italianità. Il denaro venne distribuito a pioggia sino alle elezioni del 1948, successivamente ci fu un maggiore controllo sui rendiconti delle organizzazioni, le quali, oltre alla propaganda, svolgevano un lavoro di assistenza ai bisognosi, che in cambio dovevano dar prova di sentimenti italiani. Fu infatti l’italianità il requisito necessario per accedere ai sussidi erogati dalle associazioni. Dopo le elezioni i finanziamenti si orientarono verso le associazioni più attive e dirette da personalità politiche accreditate presso il governo nazionale. Nel frattempo le associazioni si erano dotate di strutture, quali uffici, palestre, luoghi di ritrovo, di cariche e personale stipendiato, dando così lavoro ai disoccupati e ruoli di responsabilità a coloro che sarebbero poi diventati personalità di spicco della vita politica locale.
Questo provocò frizioni nel fronte nazionale, fra chi cercava di accaparrarsi le risorse più ingenti, e malintesi di fondo con l’Ufficio zone di confine, che considerava il denaro versato come «contributo» e non come finanziamento stabile. Questione sociale e questione nazionale si legarono in modo indissolubile e rappresentarono contemporaneamente un freno alla discussione politica sul futuro della ripresa economica della città. La minaccia all’italianità di Gorizia (insieme all’indelebile ricordo del «terrore titino») divenne il principale tema del discorso pubblico cittadino. I progetti di sviluppo proposti dal prefetto furono piuttosto esigui e comunque non si realizzarono se non nel lungo periodo. Solo la Zona franca venne istituita nel 1948 e anche questo provvedimento, per quanto necessario, fu ridimensionato dalle proteste di esponenti politici friulani che non vedevano di buon occhio le provvidenze a favore esclusivo della città di Gorizia. Nell’arco cronologico preso in esame sembra che la precarietà e l’urgenza della situazione goriziana, unite al «pericolo slavo», fossero non tanto ostacoli da affrontare, ma condizioni indispensabili per avere aiuti da Roma.
Anche in quello che le carte consultate definirono il «fronte avverso» ci furono conflitti determinati dal rapporto che i cosiddetti «slavi bianchi» mantennero con i partiti italiani e, dopo la rottura fra Tito e Stalin, tra i cosiddetti «slavi rossi» e il Partito comunista italiano.
La difesa dell’italianità di Gorizia mise in ombra per anni nel dibattito pubblico la necessità di elaborare quello che era stato il fascismo in queste terre, la drammaticità della guerra di occupazione in Jugoslavia e la Resistenza. Solo nel decennio successivo i rapporti tra italiani e sloveni furono meno aspri e si aprì una più seria discussione sul ruolo della città: «piccola Berlino» o città di scambi sul «confine più aperto d’Europa».